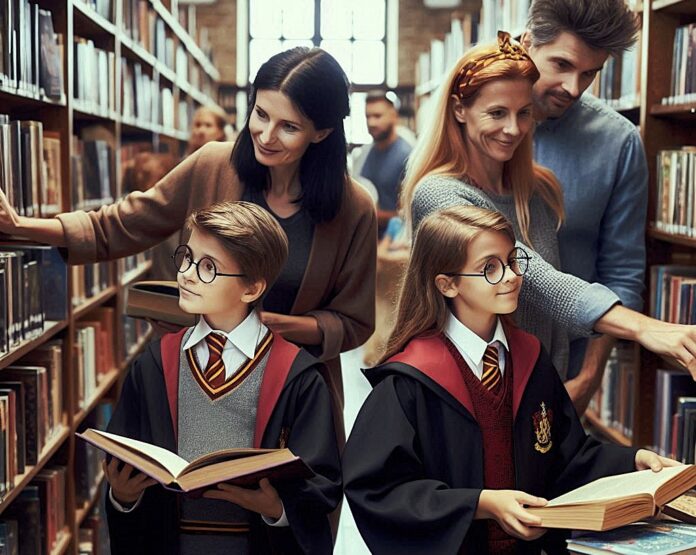Perché il rientro a scuola è così caro tra libri di testo, materiale scolastico, bonus tardivi e digitale che non sfonda? E quanto pesa sul bilancio delle famiglie? Editoriale di Tina Rossi
L’inizio della scuola non è mai un momento semplice per molte famiglie italiane, soprattutto quando si parla di acquistare i libri di testo scolastici. Ogni anno, tra fine agosto e inizio settembre, milioni di genitori si trovano di fronte a una lista che sembra non finire mai, con prezzi dei libri sempre più alti. Il carico economico che grava sulle famiglie spesso va ben oltre le aspettative e rischia di diventare un ostacolo per chi cerca di garantire un’istruzione serena ai propri figli.
Diagon Halley
Liste libri e materiale scolastico
Settembre ha un odore preciso: quaderni nuovi, copertine di plastica lucida, penne con la punta ancora intatta. Le città si riempiono di studenti che tornano a popolare le strade, con lo zaino sulle spalle e un misto di ansia e curiosità per ciò che li aspetta. Ma dietro questa scena che sembra tratta dai film di Harry Potter, si nasconde una realtà meno magica e meno poetica: il costo dei libri di testo, una voce di spesa che ogni anno mette alla prova molte famiglie.
Le liste dei libri arrivano in piena estate, spesso prima ancora che la sabbia estiva sia scesa dai costumi, e inizia la corsa alle librerie e alle piattaforme online. Si confrontano prezzi, si cercano edizioni usate, si organizzano scambi tra compagni. In alcune città, le file davanti ai negozi diventano rituali di fine estate, tra genitori che sfogliano cataloghi e studenti che controllano il peso di un atlante come fosse un bilanciere.
Ritorno a Hogwarts
Quanto costa il rientro a scuola
Secondo le ultime rilevazioni, la spesa media per i libri scolastici ha subito un aumento costante negli ultimi anni, arrivando a pesare per centinaia di euro a studente. Non si tratta solo di numeri, ma di un vero e proprio investimento per garantire a ragazzi e ragazze gli strumenti necessari per affrontare l’anno scolastico. Tuttavia, questo investimento rischia di diventare un peso sempre più difficile da sostenere per molte famiglie, già alle prese con altre spese indispensabili.
Un liceo scientifico, oggi, può richiedere libri per un valore che supera facilmente i 450 euro solo per il primo anno. Nei tecnici e nei professionali la cifra cambia, ma non scende di molto. A queste somme si aggiungono i materiali specifici — dal compasso alle squadrette per i geometri, ai testi di cucina per gli alberghieri — e le nuove edizioni, che spesso rendono inutilizzabili quelle degli anni precedenti.
Il Ministero dell’Istruzione stabilisce ogni anno dei tetti di spesa per le scuole, ma il limite si rivela spesso teorico. Basta che un docente adotti un volume fuori collana o un’edizione più recente, e il conto sale. Molti genitori si sentono con le spalle al muro: i libri sono obbligatori, il margine di scelta quasi nullo.
A fotografare il peso reale di questa spesa ci pensa il Codacons, che cita la relazione preliminare dell’Antitrust: «La spesa delle famiglie per l’acquisto dei libri scolastici è cresciuta del 13% in dieci anni, portando l’esborso a una media di 580 euro l’anno a studente per le scuole medie e 1.250 euro annui per le superiori».
La Maledizione dell’Erede
Addio ai vecchi mercatini di libri scolastici di seconda mano
Qui si apre una riflessione, anche polemica, sulla prassi ormai consolidata del business delle case editrici di cambiare qualche immagine e rielaborare qualche paragrafo nei libri per generare le “nuove edizioni”, tanto amate da insegnanti e istituti scolastici – che li scelgono – molto meno dai genitori, che li devono ricomprare.
Fino a qualche anno fa, passare i libri di figlio in figlio o acquistare un usato in buone condizioni era un piccolo salvagente economico. Oggi, quel margine si sta assottigliando fino a scomparire. L’Antitrust rileva che «le nuove adozioni da un ciclo all’altro […] sono pari al 35% nelle scuole medie e addirittura al 40% alle superiori». A ciò si aggiunge «l’odioso fenomeno delle nuove edizioni e novità […] che ogni anno riguardano il 10% dei libri scolastici».
Basta un capitolo spostato, un’immagine sostituita, una veste grafica aggiornata per rendere obsoleta una copia ancora perfetta. L’Antitrust parla apertamente di «condotte opportunistiche nella variazione di opere scolastiche attraverso nuove edizioni» e sottolinea che «l’art. 25 del Codice AIE lascia grandi margini di discrezionalità agli editori». Un meccanismo che per molti genitori ha il sapore di un abbonamento obbligatorio mascherato da aggiornamento didattico.
Il paradosso è che questo ricambio forzato colpisce tutti: i nuovi iscritti, i ripetenti, perfino chi frequenta sezioni parallele della stessa scuola. Non c’è più un vero mercato dell’usato, se non per pochi testi “resistenti” al cambio di edizione.
Il calice di fuoco
“Autunno.. è tempo di migr…” ops… di pagare
Per molte famiglie, l’acquisto dei libri di testo è un calice amaro che arriva in un momento dell’anno già economicamente impegnativo. Settembre segna la fine delle vacanze, ma anche l’inizio di una lunga stagione di spese obbligate: bollette della luce e del gas che, complice la crisi energetica, continuano a registrare aumenti; costi di riscaldamento che salgono ancora prima di accendere i termosifoni; assicurazioni auto in scadenza; tasse universitarie per i figli più grandi; rette per corsi sportivi, musica, danza o attività extrascolastiche che partono proprio in autunno.
A questi si aggiungono le spese meno visibili ma costanti: abbonamenti ai trasporti pubblici, rinnovo del guardaroba per affrontare i primi freddi, acquisto di dispositivi tecnologici richiesti per la scuola — dai tablet alle calcolatrici scientifiche — e persino le prime rate delle vacanze pagate… a rate!
Quando la lista dei libri si incastra in questo mosaico di impegni, il bilancio familiare scricchiola. Per chi ha più figli, il peso si moltiplica, e non basta un mese intero di stipendio per coprire tutte le scadenze di settembre-ottobre. In questo scenario, ogni euro conta, e vedere che molti libri “nuovi” differiscono appena da quelli dell’anno precedente alimenta un senso di frustrazione diffuso. Non si tratta di mettere in discussione l’importanza dello studio, ma di chiedere un sistema più equo, che non scarichi sulle famiglie il costo di scelte editoriali discutibili in un periodo in cui il portafoglio è già messo a dura prova.
Negli anni, le riforme pensate per ridurre l’impatto economico dei libri di testo — come l’adozione dei formati digitali — non hanno prodotto i risultati sperati. «I tetti di spesa […] si sono rivelati inefficaci», spiega l’Antitrust, e «il libro cartaceo continua a dominare le preferenze dei docenti, mentre le adozioni di soli ebook restano marginali».
Alohomora
Come fanno all’estero?
Ogni libro scolastico è, almeno in teoria, una porta aperta sul mondo. Ma se ogni anno quella porta costa di più, diventa inevitabile chiedersi se davvero serva cambiarla così spesso. Il problema non è il valore della conoscenza, ma il modo in cui viene confezionata e venduta. Per dare davvero a tutti le stesse opportunità, forse bisognerebbe fermare questa corsa alle “novità” che di nuovo hanno spesso solo la copertina.
In molti Paesi europei, la scuola ha già imboccato la strada del digitale, trasformando i tradizionali libri di testo in eBook consultabili da tablet e dispositivi elettronici forniti agli studenti. Francia, Germania, Paesi Scandinavi sono solo alcuni esempi dove l’insegnamento digitale è diventato una realtà consolidata, con piattaforme che aggiornano i contenuti in tempo reale e costi ridotti per le famiglie. Qui da noi, invece, il digitale resta una chimera spesso evocata ma poco praticata.
La mappa del Malandrino
Perchè non si investe nel digitale?
Le iniziative italiane, come le cosiddette “classi 2.0” o “3.0” (per intenderci, quelle che, in via sperimentale, utilizzano solo e-book e non libri cartacei), restano esperimenti limitati e disomogenei rispetto alle classi “tradizionali (quelle che utilizzano testi scolastici cartacei), che faticano a sfondare il muro di una scuola pubblica tradizionalista e un sistema editoriale ancorato a vecchi schemi.
Il risultato? I libri cartacei continuano a dominare le aule e le spese di settembre, mentre le adozioni di libri digitali rimangono marginali. Non solo manca un vero piano nazionale di diffusione, ma si avverte un ritardo culturale diffuso: la tecnologia si teme o si ignora, piuttosto che essere vista come uno strumento per abbattere i costi e modernizzare l’apprendimento.
Intanto il mercato resta saldamente nelle mani di pochi: «Il mercato risulta fortemente concentrato, con i primi quattro gruppi (Mondadori, Zanichelli, Sanoma, La Scuola) che coprono quasi l’80% del mercato complessivo», osserva l’Antitrust. E la dinamica è sempre la stessa: chi sceglie il libro (i docenti) non lo paga, chi lo paga (le famiglie) o lo usa (gli studenti) non lo sceglie.
Se all’estero il digitale ha già fatto breccia, perché da noi si continua a tergiversare?
Non sarà che, dietro il rifiuto – o la lentezza – di abbracciare l’innovazione, si nascondono interessi consolidati e una mancanza di visione che gravano direttamente sulle famiglie? Forse, il vero costo non è tanto quello dei libri stampati e delle “nuove edizioni” annuali, quanto il prezzo dell’inerzia e di un sistema che che ritiene più semplice e vantaggioso garantire i vecchi equilibri (soprattutto quelli economici), piuttosto che affrontare il cambiamento per costruire un futuro più sostenibile ed equo.
Il cappello parlante
Cosa si potrebbe fare
Analizzando le cifre, percentuali e dinamiche del mercato dell’editoria scolastica, la prima domanda che affiora è se sia davvero inevitabile che, ogni anno, una quota così alta dei libri di testo venga sostituita con nuove edizioni. Non si potrebbe trovare un equilibrio tra l’aggiornamento dei contenuti e la possibilità di mantenere in uso un testo per più cicli scolastici? È possibile conciliare la necessità di fornire materiali moderni e stimolanti con l’esigenza, sempre più urgente, di ridurre le spese che gravano sulle famiglie?
Viene naturale chiedersi se i tetti di spesa fissati dal Ministero, oggi poco più che indicativi, possano un giorno trasformarsi in veri argini, sorretti da controlli concreti e non lasciati alla buona volontà dei singoli istituti. Oppure se sia pensabile introdurre criteri più stringenti per definire cosa renda un’edizione realmente “nuova”, evitando che minime variazioni grafiche o spostamenti di capitoli diventino il pretesto per imporre l’acquisto di testi freschi di stampa.
Riddikulus
Rimborso dei libri di testo e bonus scolastici
Certo, qualche strumento di sostegno esiste. Contributi regionali, voucher comunali, bonus libri: ammortizzatori che sulla carta promettono di alleggerire il peso. Ma quasi sempre arrivano dopo, quando le famiglie hanno già anticipato centinaia di euro e magari fatto i conti con un conto corrente alleggerito. È un aiuto o un semplice rimborso tardivo? E, soprattutto, quanti possono davvero accedervi senza perdersi tra moduli, scadenze e requisiti? Forse dovremmo chiederci se un sistema che rimborsa dopo sia davvero pensato per aiutare prima. Non sarebbe più logico trovare meccanismi che evitino alle famiglie di dover affrontare, ogni settembre, una spesa che somiglia a una tassa scolastica non dichiarata — e per di più in un sistema di scuola pubblica che, per definizione, dovrebbe garantire accesso equo e gratuito all’istruzione di base.
E allora, la vera domanda è se vogliamo continuare a considerare “normale” questo meccanismo o se, prima o poi, ci decideremo a chiederci perché l’istruzione gratuita in Italia sembri costare, ed ogni anno sempre di più. Perché se la scuola è davvero di tutti, acquistare gli strumenti indispensabili non dovrebbe essere un lusso che, a settembre, qualcuno può permettersi più facilmente di altri.
Immagine di copertina generata con IA Bing
Potrebbe interessarti anche:
Scuola e caro libri, si preannuncia un salasso: di quanto sale la spesa
Cellulari vietati alle superiori: siamo pronti a questa sfida?