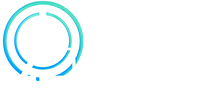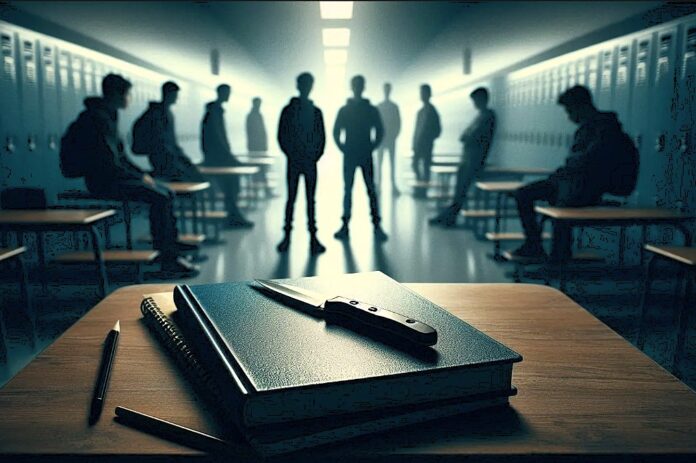Dal caso La Spezia ai coltelli a scuola: conflitti tra pari e fragilità emergono tra i giovani e il contesto educativo attuale. Editoriale di Tina Rossi
Portare coltelli a scuola è una “moda” che riguarda molte scuole italiane, indistintamente da nord a sud, dalle periferie al centro, e il recente episodio avvenuto in un istituto scolastico di La Spezia è solo il tragico risvolto di un problema ben più ampio e che riporta al centro dell’attenzione questioni che attraversano da tempo la scuola italiana: la fragilità emotiva degli adolescenti e la gestione dei conflitti. Non mi soffermerò nel descrivere i dettagli di cronaca, ormai pietosamente noti, ma mi concentrerei sulle giovani generazioni, sugli spazi educativi e su un gesto che ha superato un limite netto. E’ pleonastico dire che uccidere un compagno di classe per gelosia, portare coltelli a scuola – notizia recente: anche un macete – e brandirli davanti ai compagni, è un fallimento sociale e culturale.
La scuola entra nella cronaca come simbolo di un luogo che la società considera sicuro e protettivo, ma che in realtà riflette fragilità profonde. Ogni episodio simile genera domande sul ruolo reale del sistema scolastico: che cosa si aspetta oggi la società dalla scuola? Quali funzione e ruolo possiamo davvero attribuirle senza sovraccaricarla? Come possono dare spazio alle emozioni dei ragazzi senza che queste degenerino in gesti estremi?
Oltre la cronaca
Il fatto di cronaca diventa così un indicatore di problemi più ampi, tra cui la difficoltà di riconoscere e verbalizzare emozioni complesse, come la gelosia, l’insicurezza, il disagio sociale e famigliare e la necessità di strumenti simbolici che aiutino a elaborarle. La scuola non è solo luogo di istruzione, ma laboratorio di relazioni, spazio dove le regole, le aspettative sociali e le emozioni si confrontano continuamente. Quando questi meccanismi falliscono, ogni gesto estremo di violenza appare improvviso, ma in realtà è l’esito di dinamiche silenziose accumulate nel tempo. La società tende a cercare colpe e a isolare cause, ma la complessità dei processi emotivi richiede osservazione e comprensione.
È su questo terreno che si può iniziare a parlare di fragilità interna, di insicurezze, e della gelosia morbosa come indicatore più profondo che non può essere ridotto a semplice comportamento deviante.
La cronaca di questi eventi tra adolescenti tende a durare pochi giorni e trovano subito giustificazioni in concetti generici: emergenza educativa, disagio giovanile, fallimento delle famiglie, mancanza di valori. Sono parole diventate un cliché nei talk show e nei salotti mediatici, ma che spesso restano vuote e prive di collegamento con le esperienze concrete dei ragazzi. La riflessione richiesta dalla cronaca va oltre il gesto, invitando a interrogarsi sul contesto emotivo e relazionale in cui gli adolescenti crescono.
Ogni giovane attraversa un periodo intenso e complesso fatto di trasformazione fisica e di costruzione identitaria, dove emozioni forti, paure e desideri si mescolano e si amplificano. La scuola diventa lo specchio di queste tensioni: le relazioni tra pari, il confronto quotidiano, la competizione implicita e il bisogno di riconoscimento producono fragilità visibili.
Crescere è sempre stato così, e per tutti.
Cosa è cambiato?
Tutti abbiamo vissuto momenti di insicurezza, gelosia o paura del giudizio. È un percorso evolutivo dell’essere umano, una fase in cui si definisce sé stessi e il proprio posto nel mondo.
Ma perché oggi sembra più difficile? Che cosa è cambiato rispetto a venti, trenta o quaranta anni fa?
Dipende forse dalla velocità dell’informazione, dalla pressione sociale, dal confronto costante con modelli idealizzati? Oppure è la percezione stessa di fragilità a essere amplificata da contesti allargati e, forse, più esigenti, dove le emozioni dei ragazzi non trovano spazio e linguaggio adeguato?
La società pretende dalla scuola risposte immediate, ma gli strumenti disponibili spesso non sono sufficienti. Il linguaggio emotivo, le strategie di contenimento dei conflitti e la capacità di mediazione non sono automatizzati ma si apprendono e si sviluppano nel tempo.
Il fatto di cronaca è dunque solo la punta di un iceberg. La vera domanda riguarda come la società stessa costruisce modelli emotivi che arrivano tra i banchi e quali spazi lascia alle emozioni dei giovani per essere espresse senza trasformarsi in azioni violente.
Che cosa pretende la società dalla scuola?
La scuola è diventata un contenitore di funzioni multiple. Non deve solo insegnare, ma anche contenere conflitti, prevenire violenze, intercettare segnali di disagio psicologico, compensare carenze sociali e famigliari, garantire sicurezza emotiva e fisica. Spesso le risorse non sono adeguate: classi affollate, docenti sotto pressione, strumenti limitati. A questo si aggiunge una crescente eterogeneità delle aule, dove convivono studenti con background culturali, linguistici e familiari molto diversi, e, di conseguenza, la complessità aumenta, ma le strutture restano le stesse di venti o trent’anni fa. Il paradosso è evidente: maggiore è il carico di aspettative, più ogni episodio critico viene interpretato come fallimento totale.
Ma la domanda che ci si dovrebbe porre è diversa e più scomoda: è davvero compito della scuola individuare queste fragilità o risolverle? Possiede gli strumenti per farlo?
O siamo noi, come società che, delegando alla scuola responsabilità impossibili, rischiamo di perdere di vista la radice dei problemi?
In fondo, le tensioni emotive, le insicurezze e i conflitti delle giovani generazioni nascono altrove: in famiglia, nei gruppi di pari, nei modelli culturali e mediatici che li circondano. La scuola le intercetta come un segnale, non come causa. È un luogo di passaggio, uno specchio di ciò che la società produce, non la fabbrica dei comportamenti devianti.
La moglie ubriaca e la botte piena
Il nodo della questione è che esistono una serie di paradossi che dominano nella nostra società.
Genitori che pretendono insegnamento e autorità, ma che reagiscono con rabbia, a volte persino aggressività, se il loro figlio prende un brutto voto o viene punito per un comportamento scorretto.
E che dire dei docenti? Si vuole che siano severi e autorevoli, capaci di imporre limiti, ma senza mai ferire. Che giudichino senza giudicare, che correggano senza umiliare, che pretendano senza creare frustrazione. Che promuovano tutti per proteggere, alleggeriscano carichi e scadenze, riducano verifiche, non assegnino compiti nelle vacanze. Una scuola “accogliente” e rassicurante, incapace di educare al confronto, alla disciplina e alla responsabilità.
Si pretende che la scuola tenga i ragazzi al sicuro, li tolga dalla strada, li protegga e li rassicuri. Ma se togliamo l’autorevolezza e l’autorità alle istituzioni scolastiche, quando dovranno affrontare la vita reale, non avranno gli strumenti per farlo. Non sapranno confrontarsi con fallimenti, responsabilità, limiti e regole. Inoltre, non sono preparati al mondo del lavoro, non sanno gestire errori o conseguenze, perché il sistema scolastico, così come è strutturato oggi, non fornisce la giusta formazione.
Il risultato è, appunto, un paradosso. La scuola è sottoposta a richieste impossibili: deve proteggere senza preparare, deve includere senza giudicare, deve educare senza punire. I ragazzi crescono senza capire che nella vita reale le regole esistono e i docenti restano figure contraddittorie, chiamati a fare miracoli in un sistema che pretende tutto e allo stesso tempo impedisce loro di insegnare davvero.
Quando l’emozione non ha voce
Molti adolescenti non trovano linguaggio per esprimere ciò che provano. La scuola spesso intercetta solo l’esito finale. L’acting out è un modo indiretto di comunicare conflitti inconsci e diventa sostitutivo del pensiero quando manca la capacità di riconoscerli ed esprimerli con la parola, generando insicurezze, ansia e paura.
Le risposte dell’ambiente modulano questa dinamica. In alcuni contesti, comportamenti difensivi vengono normalizzati: l’adolescente impara che la violenza è uno strumento di protezione e sopravvivenza. In altri, le stesse emozioni vengono contenute, e il giovane impara a trovare vie simboliche per esprimerle, come l’arte, la musica o lo sport, e in altri ancora, non ci sono alternative: né spazio, né ascolto, né mediazione.
La domanda che emerge è provocatoria: quanto può la scuola realmente intervenire sul conflitto interno dei ragazzi? E quanto invece questo compito appartiene a un insieme più ampio di responsabilità che riguardano famiglia, comunità, cultura e modelli sociali? L’acting out, in questo senso, diventa specchio delle fragilità che vengono da altrove e che hanno origine nel contesto storico e sociale contemporaneo che viviamo.
La famiglia
Il giovane non cresce isolato: le sue paure, le insicurezze e la capacità di gestire emozioni complesse si intrecciano con il mondo che lo circonda, ma il contesto familiare contemporaneo, spesso, non offre più un terreno solido su cui costruire identità e sicurezza emotiva. Rispetto al passato, troppo sovente, la famiglia non rappresenta più un rifugio stabile, un luogo in cui condividere tempo, esperienze e sostegno reciproco. Molti genitori lavorano tutto il giorno, a volte anche la domenica, e i figli vengono affidati a nonni, educatori, allenatori o attività extracurricolari.
Anche se, in ogni caso, la presenza fisica da sola non basta: ciò che conta è la qualità del tempo condiviso, la capacità di ascolto, il dialogo e la costruzione di rituali quotidiani che creano punti di riferimento stabili. Senza questi, il ragazzo percepisce la casa non come spazio sicuro, ma come luogo frammentato, dove le emozioni intense non trovano interlocutori affidabili ed è frequente che il mondo virtuale – o la strada – diventi quel posto “sicuro” dove cercare consensi e realizzazione.
Chi è genitore e chi è figlio?
A questo quadro si aggiunge una trasformazione più sottile e psicologicamente incisiva: molti genitori cercano di essere “amici” dei propri figli, condividendo giochi, social, hobby e momenti di svago come se fossero pari, replicando comportamenti e linguaggi tipici dei coetanei. TikTok, selfie, balletti, ore passate alla console insieme: tutto questo diventa un boomerang quando il genitore deve poi rappresentare autorevolezza – ma anche autorità – e mettere dei limiti. Essere complice è possibile e salutare, essere amico, invece, è innaturale, perché il confine tra gioco e guida, tra dialogo e regola, rischia di dissolversi. Quando il giovane cresce in un contesto simile, non sviluppa percezione chiara di sé, fatica a riconoscere i propri limiti, i propri desideri e le proprie responsabilità, e resta confuso rispetto alla realtà di chi è e di che adulto sarà.
In altri casi, invece, troviamo genitori “succubi” dei figli: cedono a qualsiasi richiesta per compensare assenza e senso di colpa, per paura di perdere affetto o approvazione. Tutto diventa negoziazione: ogni “no” diventa difficile da imporre, ogni limite rischia di trasformarsi in conflitto, e ciò che il genitore concede passa dal ruolo educativo a quello di ricatto emotivo involontario. In molte famiglie, il confine tra autorità e complicità è sfumato, i no sono negoziabili e la punizione è assente o incoerente.
Il risultato è che l’adolescente impara così che i confini sono flessibili, che il potere emotivo può essere manipolato e che l’assenza di guida solida può essere aggirata.
E poi c’è il meraviglioso mondo dei social.
La tecnologia amplifica queste dinamiche. Genitori e figli spesso passano ore separati davanti a schermi diversi: il primo tra mail, social, chat e selfie; il secondo tra videogiochi, social e media digitali. Il contatto reale diminuisce, le conversazioni autentiche si riducono e l’adolescente resta isolato nel suo mondo emotivo. I modelli social mostrano successi illimitati, libertà senza confini e norme flessibili, aumentando ansia, frustrazione e senso di inadeguatezza.
In questo contesto, l’acting out emerge come esito naturale di tensioni accumulate. Le emozioni non trovano linguaggio né contenimento, la gelosia, l’ansia e la frustrazione non si trasformano in pensiero o dialogo, ma in comportamenti concreti, visibili, talvolta estremi. L’adolescente cresce dissociato dalla realtà e dal suo ruolo in essa, incapace di distinguere limiti e regole, senza percezione chiara del proprio sé in relazione agli altri “sé”, perché la guida educativa non è più stabile né coerente.
La provocazione è evidente: quanto può davvero la scuola intervenire quando le fragilità nascono in contesti familiari e sociali così disallineati? Quanto può compensare assenze emotive, confusione nei ruoli, modelli digitali e social che amplificano ansia e insicurezza?
Il problema non è isolato: richiede un ecosistema più ampio, in cui la società, la famiglia, la comunità e gli strumenti culturali e educativi forniscano linguaggio, contenimento e punti di riferimento chiari prima che la fragilità interna trovi sbocco nelle azioni all’esterno. È in questo spazio — tra responsabilità sociale, dialogo autentico e guida autorevole — che si può iniziare a comprendere perché alcuni ragazzi reagiscono con comportamenti estremi e come sia possibile intervenire prima che l’angoscia diventi una tragedia reale.
La gelosia come segnale di fragilità psicologica
Nel caso di La Spezia, il movente parrebbe essere la gelosia, che emerge come uno dei segnali più chiari di fragilità emotiva. Freud scriveva che “la gelosia può assumere forme normali, proiettate o deliranti”, sottolineando che spesso il sentimento riflette conflitti interni più che azioni dell’altro.
John Bowlby osservava che “la separazione precoce o l’insicurezza nell’attaccamento genera ansia e comportamenti di ricerca di conferme”, un concetto utile per capire perché adolescenti con attaccamento ansioso vivano la gelosia in modo intenso.
Mary Ainsworth mostrava che chi sviluppa attaccamento ansioso tende a cercare rassicurazioni continue, comportamenti spesso percepiti come eccessivi o ossessivi. Aaron Beck e Albert Ellis indicano come schemi cognitivi di svalutazione personale, come “non sono abbastanza” o “posso essere facilmente sostituito”, alimentino la gelosia e la rendano difficilmente gestibile.
Heinz Kohut e Otto Kernberg sottolineano che individui con fragilità narcisistica percepiscono ogni possibile perdita come minaccia alla propria identità. La gelosia, in questo quadro, non è rabbia verso l’altro, ma espressione di un’angoscia interna e di una incapacità di gestire emozioni complesse e bassa autostima.
Tutti fattori di una stessa equazione: quando l’autostima è debole, ogni confronto diventa percepito come minaccia. La gelosia cresce come risposta alla sensazione di vulnerabilità. Gli adolescenti che non hanno spazi per esprimere emozioni complesse si trovano a gestire ansie e insicurezze in modo diretto o simbolico. Freud e Bowlby concordano sul fatto che questi vissuti non sono improvvisi, ma il risultato di anni di esperienze emotive e relazionali. In assenza di strumenti simbolici, l’angoscia cerca un oggetto o un gesto per emergere, spesso concretizzandosi in comportamenti aggressivi.
La psicologia non giustifica l’azione, ma permette di comprenderne la radice. Il gesto estremo non nasce dal nulla: è la manifestazione visibile di dinamiche interne accumulate, dove la gelosia agisce da segnale e amplificatore di fragilità.
Mancata integrazione o disagio soggettivo?
In alcuni contesti sociali e culturali, oggetti contundenti come tirapugni o coltelli, vengono percepiti come strumenti quotidiani di protezione. Non sono percepite come armi, ma come estensioni della sicurezza personale. La scuola, come spazio neutro, entra in conflitto con questi significati. Il divieto è necessario – anzi indispensabile – ma non basta.
A tal proposito è facile cadere nella banale spiegazione che portare armi è una “usanza” di alcune “etnie”, e circoscrivere il problema a una mera disquisizione razziale.
Il problema non è l’origine culturale degli studenti, ma l’apprendimento precoce di modalità di difesa che diventano automatiche. Capire questo aiuta a evitare letture etniche o moralistiche semplificate e permette di affrontare la questione in termini educativi e sociali.
Portare un’arma bianca per sentirsi al sicuro è una risposta concreta a un bisogno percepito. Crescere in contesti dove il rischio è reale produce strategie di difesa precoce. La scuola non è attrezzata per gestire simbolicamente queste logiche. La soluzione non è solo proibire, ma fornire strumenti simbolici per elaborare paure e insicurezze.
La distinzione tra mancata integrazione e disagio individuale, dunque, non è netta, ma si intrecciano. L’integrazione richiede accesso a codici condivisi e strumenti emotivi. Il disagio soggettivo attraversa tutti i contesti. La gelosia, l’insicurezza, la paura della perdita non hanno confini etnici. Ridurre il fenomeno a una sola dimensione significa ignorarne la complessità.
Il vuoto etico
Il coltello a scuola non è mai un fenomeno isolato. Dietro un gesto simile si intrecciano fragilità emotive, contesto familiare, cultura di appartenenza e modelli mediatici che amplificano insicurezza e desiderio di status ma, più di tutto, si manifesta un tragico vuoto etico, e in questo vuoto etico il coltello assume significati simbolici amplificati dalla fascinazione mediatica: serie TV – come Gomorra, per fare un esempio su tutte – mostrano la violenza come glamour, spettacolarizzando sangue e tragedia fino a renderla intrattenimento.
Il genere crime – peggio ancora lo splatter – nelle serie TV e nel cinema tracima di scene sanguinose e normalizza la morte, riducendo la capacità dei giovani di percepirne la gravità reale. I videogiochi, con la loro logica delle “tre vite”, insegnano che la morte è reversibile: si muore, game over, si ricomincia. Questo banalizza le conseguenze, impedisce di interiorizzare la responsabilità reale e rinforza la percezione che il rischio sia gestibile, controllabile o addirittura inesistente.
Il principio di responsabilità
Nel 2025, secondo una ricerca dell’Istituto di fisiologia clinica del Cnr, circa 87 mila studenti tra i 15 e i 19 anni , pari al 3,5 % degli iscritti alle scuole superiori, hanno usato un coltello in ambito scolastico per intimidire o ferire qualcuno (fonte Orizzontescuola).
Il coltello diventa allora mezzo concreto di protezione, estende la sensazione di controllo, amplifica il concetto di potere e crea una falsa percezione di onnipotenza. Non è solo strumento di difesa: è simbolo di status, capacità di imporre sé e di manipolare paura e autorità. La realtà e le conseguenze concrete del gesto restano distanti, astratte, come avviene nei media, nei videogiochi e nelle narrazioni digitali.
Il pensiero di Hans Jonas illumina questa dinamica: “Ciò che oggi è temibile è la nascita di un nichilismo nel quale il massimo di potere si unisce al massimo di vuoto, il massimo di capacità al minimo di sapere intorno agli scopi. In nome del progresso della scienza sono stati aboliti o non posti certi limiti con la conseguenza che il senso stesso del limite diventa sempre più precario”.
E ancora: “La morte non appare più come una necessità insita nella natura di ciò che è vivo, ma come una prestazione organica disfunzionale a cui si può porre rimedio”. I giovani crescono in un mondo dove la vita e le conseguenze dei propri atti non appaiono come limiti naturali da rispettare, ma come elementi elastici o rimediabili, riducendo il senso di responsabilità.
Di chi è la colpa?
Sono gli adulti che costruiscono modelli emotivi e determinano quali emozioni possono essere espresse. Se il disagio soggettivo viene ignorato o banalizzato, perde possibilità di elaborazione. La scuola può facilitare il riconoscimento delle fragilità prima che diventino gesti estremi. Il fatto di cronaca è solo la proiezione di un sistema sociale, culturale e politico.
La scuola intercetta l’esito finale: il gesto concreto, improvviso, percepito come minaccia. Ma le radici – vuoto etico, fascinazione mediatica e mancanza di punizione coerente – restano invisibili.
E allora resta un’ultima domanda: quanto può prevenire la scuola senza una rete più ampia di regole, valori, punti di riferimento e consapevolezza del limite? Quanto diventa urgente, oggi, recuperare senso di responsabilità e percezione reale delle conseguenze, prima che il fascino del gesto diventi azione concreta?
Potrebbe interessarti anche:
“Sapeva che avrebbe ucciso Youssef”, il gip non crede alla versione di Atif e convalida l’arresto
Sora, studente accoltellato davanti a scuola: caccia all’aggressore
Microcriminalità e baby gang: quando rientrare a casa fa paura
Immagine di copertina generata con IA
Unisciti a Zetatielle Magazine su Linktr.ee e ascoltaci su RID968.