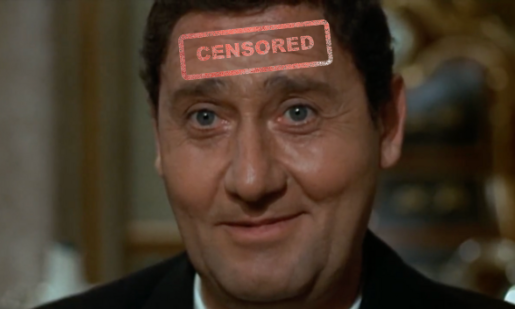Politically correct e cancel culture: non è che stiamo esagerando? Editoriale di Tina Rossi
Vi ricordate i bei tempi in cui si poteva dire tutto senza pensare troppo alle conseguenze? Quei tempi in cui uno poteva esprimersi liberamente senza rischiare di finire su una gogna mediatica, virtuale o reale? Bene, dimenticateli.
Siamo entrati nell’epoca del politically correct e della cancel culture, un’epoca in cui ogni parola deve passare al vaglio di un tribunale invisibile fatto di social, sensibilità esasperate e tanta, tanta paura di sbagliare.
Ma cos’è questo politically correct, esattamente? E, soprattutto, come siamo finiti in un mondo in cui chiamare “ragazzi” un gruppo misto di uomini e donne è considerato un atto di micro-aggressione?
Politically correct: quando “essere gentili” diventa una gabbia
In teoria, il politically correct nasce con buone intenzioni: evitare di offendere o discriminare le persone per il loro genere, colore della pelle, orientamento sessuale, religione e via dicendo. Un principio nobile, no? In pratica, però, è diventato un gigantesco gioco al massacro, dove ogni parola detta può essere analizzata, contestata e interpretata nel modo peggiore possibile.
Provate a dire “signore e signori” in una sala conferenze. Qualcuno potrebbe alzarsi e gridare: “E le persone non binarie? Dove le mettiamo?” Oppure, usate “loro” invece di “lei” parlando di una donna e preparatevi a sentirvi dire che avete cancellato la sua identità. Insomma, parlare è diventato un campo minato.
E qui l’italiano medio inizia a chiedersi: “Ma non è che stiamo un po’ esagerando?”
Cancel culture: quando un errore ti costa la reputazione (e il lavoro)
Il politically correct, però, ha una cugina ancora più temibile: la cancel culture. Se il primo ti invita a scegliere le parole con cautela, la seconda ti punisce senza pietà quando sbagli. Non importa se hai fatto uno scivolone dieci anni fa o ieri: la rete non dimentica, e le orde di giustizieri digitali sono pronte a farti pagare.
Un comico fa una battuta scomoda su Twitter? Licenziato. Un attore usa un termine poco appropriato in un’intervista? Rimosso dal film. Un influencer posta una foto di carnevale con un costume “culturalmente insensibile”? Cancellato dalla faccia di Instagram.
Ma attenzione: non si tratta solo di punire chi ha detto o fatto qualcosa di discutibile. Spesso, la cancel culture si accanisce anche su chi è semplicemente frainteso. Perché, diciamocelo, capire il contesto richiede tempo, e chi ha tempo per leggere l’intero post quando si può urlare “vergogna” nei commenti?
Politically correct e razzismo: quando cambiare le parole non basta a cambiare i fatti
Viviamo in un mondo dove sui social tutti si indignano a suon di hashtag: #StopRazzismo, #NoHate, #SiamoTuttiUguali. E va benissimo, eh! Ma poi, nella vita reale, la situazione sembra un tantino diversa. È come se il politically correct fosse il filtro Instagram della società: rende le cose più belle in superficie, ma sotto sotto i problemi restano. Prendiamo i politici, per esempio. Alcuni parlano di “flussi migratori” con l’aria di chi sta discutendo di un’invasione aliena, ma poi aggiungono: “Non sono razzista, ho molti amici stranieri!” (Di solito sono “amici” immaginari, come il cugino che lavora alla NASA).
E sui social? Basta un post di un influencer che parla di inclusività per ricevere una valanga di commenti tipo: “Se non ti sta bene, tornatene al tuo Paese!” Ma attenzione: rigorosamente scritto sotto il nome di un utente con la bandiera italiana e il cuore nel profilo. Insomma, il politically correct ci insegna a dire “persona di origine straniera” invece di “straniero,” ma non sembra aver insegnato a molti che negare una casa in affitto a qualcuno perché ha la pelle scura è razzismo, punto.
Alla fine, il politically correct contro il razzismo è un po’ come usare una benda su una frattura scomposta: è un inizio, ma non risolve il problema. Forse, dovremmo smettere di preoccuparci solo di come diciamo le cose e iniziare a preoccuparci di come le facciamo. Ma, per carità, non troppo in fretta: rischiamo di rompere l’internet.
Qualche numero
Se quello che avete appena letto vi ha indignato, sappiate che non è solo farina del mio sacco, ma si evince anche dal rapporto ufficiale del Censis. Il politically correct spesso ci invita a scegliere con cura le parole per evitare discriminazioni, ma il razzismo rimane un problema che va oltre il linguaggio. Secondo il Censis, ben il 40,8% degli italiani è convinto che la nostra società sia razzista, con la percentuale che sale al 47,2% tra i giovani dai 18 ai 34 anni.
Per chi vive il problema sulla propria pelle, la situazione appare ancora più grave: oltre il 62% dei giovani di seconda generazione ha subito discriminazioni in passato, e il 26% ne è ancora vittima oggi. Non si tratta solo di episodi isolati: il 23,4% si è visto negare un impiego per le proprie origini, e il 29,4% non ha potuto affittare una casa perché percepito come “straniero”.
Le cifre sono impietose anche sui crimini d’odio, che in Italia sono più che raddoppiati in otto anni: da 555 nel 2015 a ben 1.393 nel 2022. Di questi, quelli motivati da razzismo o xenofobia sono quasi triplicati, passando da 369 a 1.105 (+199,4%). Numeri che fanno riflettere e che confermano il sentimento del 64,4% dei giovani di origine straniera, convinti che il razzismo stia aumentando. Insomma, il politically correct può anche correggere il linguaggio, ma non può cancellare un problema così radicato.
C’è troppa frociaggine
Lo ha detto il Papa. Non uno qualunque, ma proprio Papa Francesco, il pontefice noto per la sua apertura mentale. La frase è stata riportata dai media e, inutile dirlo, ha scatenato il caos. Certo, con una battuta così, il politically correct ha avuto un colpo apoplettico. Eppure, questo ci offre uno spunto di riflessione: quanto è davvero cambiato l’atteggiamento verso la sessualità in Italia?
Da una parte, ci vantiamo di essere più inclusivi: Pride che colorano le città, testimonial LGBTQ+ che spopolano nelle pubblicità, e serie TV che finalmente raccontano amori che escono dagli schemi. Ma sotto la superficie, la realtà è un’altra. Frasi come “Non ho nulla contro i gay, però…” sono ancora il pane quotidiano. La discriminazione non si ferma: un ragazzo su tre in Italia racconta di aver subito episodi di omofobia, spesso nel silenzio generale.
E poi ci sono i paradossi. Mentre ci scandalizziamo se un cantante osa fare coming out in diretta, il nostro cinema celebra da decenni personaggi come Alvaro Vitali, che si vestiva da donna per far ridere. Ridiamo con Christian De Sica quando fa battute su travestiti nei film natalizi (ne parleremo qualche riga più avanti), ma ci blocchiamo se un politico osa proporre corsi scolastici sul rispetto delle diversità.
Insomma, siamo un Paese dove tutto è permesso, purché rimanga nel perimetro del “fare due risate”. Ma guai a chiamarlo amore. È qui che il politically correct mostra tutti i suoi limiti: possiamo cambiare le parole, ma finché le idee non cambiano, rimarremo sempre un po’ prigionieri della “frociaggine” che ci fa paura.
Quando il cinema non era politically correct (e tutti vivevano felici e contenti)
Censurare il passato per adattarlo al presente è come cercare di far indossare un paio di skinny jeans a una statua romana: inutile e vagamente ridicolo. Il cinema, l’arte e la musica hanno tranquillamente spaziato nei vizi e nel bigottismo italiano senza tutto lo scalpore e l’indignazione di oggi.
La lista è infinita: il primo film della saga Vacanze di Natale, un caposaldo della commedia italiana, oggi farebbe sobbalzare le sedie dei benpensanti:
Maschi contro femmine ci farebbe rischiare una rissa con gli attivisti per l’uguaglianza di genere.
Applicare una cancel culture e censurare tutto equivale a negare la nostra storia. E ammettiamolo: è davvero utile discutere di cosa non ci piace del passato? Anche perché, diciamocelo: se cancellassimo tutto, che ci rimarrebbe da guardare o ascoltare? Solo i tutorial di cucina su TikTok.
Ma dobbiamo proprio rivisitare tutto, riscrivere ogni canzone, film? L’arte e la cultura del passato sono il riflesso del loro tempo, non una bozza da correggere con le regole del 2024.
Ironia e politically correct: un matrimonio impossibile?
Per l’italiano medio, che ama la sua pasta al dente, le battute al bar e i meme su Facebook, questa situazione è disarmante. Da una parte, c’è chi gli dice che deve aggiornarsi, che non può più fare certe battute o dire certe cose. Dall’altra, c’è la sua voglia di vivere tranquillo, senza dover imparare il glossario dei pronomi o fare un corso accelerato sulla storia del colonialismo ogni volta che apre bocca.
E così, l’italiano medio si trova davanti a un dilemma esistenziale: adattarsi o ribellarsi?
Forse la vera tragedia del politically correct è che ha reso l’ironia un’arte pericolosa. Chi osa scherzare rischia di essere frainteso. Una battuta innocente sul fatto che in Italia abbiamo più santi che giorni dell’anno può essere interpretata come un attacco alla fede cattolica. E se osi ridere delle mode alimentari, attenzione: potresti essere accusato di discriminare i vegani.
Ma l’ironia è il cuore della cultura italiana. Come facciamo a sopravvivere senza?
Forse è per questo che tanti italiani guardano al passato con un pizzico di nostalgia. Era davvero un’epoca migliore? Non necessariamente. Ma almeno si poteva fare una battuta senza temere di essere linciati virtualmente. Si poteva discutere, anche animatamente, senza che il dissenso fosse etichettato come odio.
Quando chiamarsi Manuel Negro diventa un problema
Pensateci: Fausto Leali che canta “Angeli negri” negli anni Sessanta. O Edoardo Vianello che celebra “Siamo i Watussi, gli altissimi negri” in quella che era una canzone leggera e spensierata. Oggi rischierebbero di essere banditi dalle playlist e marchiati con il bollino della vergogna culturale.
Intanto, ancora oggi, il film di Natale per eccellenza resta “Una poltrona per due“: ma siamo sicuri che potremo ancora guardarlo in versione integrale?
A proposito, quest’anno a Natale, ritornerà nelle sale cinematografiche italiane la versione “restaurata”. Sono proprio curiosa di vedere se è cambiato il doppiaggio di questa scena:
E che dire del mio amico Manuel Negro? E’ già politicamente scorretto già nel nome!
Dovrebbe cambiare cognome per non urtare la sensibilità altrui? A quanto pare, si!
Il suo cognome è diventato un vero problema, per un cabarettista di successo che con il pubblico e i social ci lavora.
Cito testualmente: “Facebook non promuove i miei contenuti perchè non rispettano le regole della community. L’algoritmo legge “Negro” e pensa che sia un contenuto razzista“.
E non è l’unico caso in cui si ritrova “nei guai”:
Il paradosso italiano: tra regole per i media e fastidio per il politically correct
Il 58°rapporto Censis ci ricorda che noi italiani abbiamo un rapporto complicato con le parole. Da una parte, emerge un forte consenso (oltre il 70% degli intervistati) a favore di regole che guidino i media nell’uso di un linguaggio rispettoso verso categorie come persone con disabilità, differenze religiose, orientamento sessuale, identità di genere e specificità etniche e culturali. Addirittura, il 76,9% si dichiara favorevole a una maggiore attenzione verso termini legati all’aspetto fisico, come quelli riferiti a sovrappeso o obesità. Fin qui, sembrerebbe che il politically correct sia visto come un progresso.
Ma ecco il colpo di scena: quando si passa al linguaggio quotidiano, la storia cambia. Ben il 69,3% degli italiani ammette di sentirsi infastidito dalla presenza costante di persone pronte a offendersi per ogni frase “inopportuna”. E sulla cancel culture? Qui il dato è ancora più netto: solo il 21,4% pensa che le opere d’arte del passato che possono urtare la sensibilità di qualcuno vadano messe da parte. Insomma, regole sì, ma senza esagerare e, francamente, più che per la vita del politically correct, personalmente sono molto più preoccupata per la morte del congiuntivo.
E qui lascio la parola al collega Roberto Parodi, ma non andate, via, perchè ho ancora qualcosa da dire.
Un compromesso possibile?
Quindi, qual è la soluzione? Possiamo trovare un equilibrio tra il rispetto delle sensibilità altrui e la libertà di espressione?
Forse sì, ma richiede uno sforzo da entrambe le parti. Ma cambiare le parole senza cambiare le mentalità è come mettere il profumo su una pattumiera: l’odore resta. Da un lato, chi abbraccia il politically correct deve imparare a distinguere tra un’offesa intenzionale e un semplice errore. Dall’altro, chi si sente oppresso da questa cultura deve accettare che alcune frasi o comportamenti pesano a seconda del contesto.
L’importante è ricordare che, alla fine, siamo tutti esseri umani. Sbagliamo, impariamo, ci adattiamo. E magari, ogni tanto, riusciamo ancora a ridere insieme.
Chissà cosa direbbe oggi Alberto Sordi
Foto di copertina da Wikimedia Commons
Potrebbe interessarti anche:
Un torneo di briscola fa insorgere gli animalisti