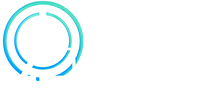È su Netflix la docu-serie da 4 mini-episodi che mostra i trent’anni di carriera di Sean Combs (Puff Daddy), capo della Bad Boy Records tra accuse, stupri e violenze. Oggi mi sento polemico e ho bisogno di parlarne.
Permettetemi di essere da subito sincero: questa non sarà una recensione.
Non starò qui a parlavi di aspetti tecnici o qualitativi di questa opera diretta da Alexandria Stapleton.
Anzi, vi tolgo subito il dubbio, il documentario prodotto da 50 Cent contro Puff Daddy a me è piaciuto e lo considero di ottima fattura. Quindi ve lo consiglio perché oltre ad essere ben fatto dà modo di riflettere, non solo sulla vita professionale e privata di Sean “Diddy” Combs (Puff Daddy), ma anche sulle sue vittime.
La docuserie ha fatto e sta facendo ancor più discutere perché al di là degli impressionanti avvenimenti che tratta, si trova nel bel mezzo di una diatriba legale tra Diddy e Netflix. Il team del produttore discografico sostiene che il documentario mostri presunti “filmati rubati” (i video in questione sono filmati girati dallo stesso Puff Daddy). Stapleton ribadisce che il tutto è stato ottenuto legalmente e che la squadra di Combs è stata contattata più volte senza ricevere alcuna risposta.
Allora, iniziamo: la violenza è sempre ingiustificabile.
Non esistono attenuanti, non esistono “ma”, non esistono contesti che possano renderla accettabile.
Detto questo, una cosa va chiarita subito: guardando il documentario è impossibile non provare disgusto e ribrezzo. Non solo per Puff Daddy come artista o imprenditore, ma anche per la persona che emerge dal racconto.
E no, non si tratta di una “caduta dell’idolo”. Si tratta di smettere di fingere di non sapere che il potere possa funzionare come una patente di impunità morale.
Il mito del genio è finito
Puff Daddy è stato celebrato per anni come visionario, king maker, architetto di un impero. Osannato come un Dio, ricercato a più non posso dai mass media, uomo copertina d’innumerevoli magazine che hanno risonanze anche oltreoceano. Tutto vero.
Eppure la sua è una delle storie più classiche e comuni al mondo, quelle storie lette nei libri o viste nei film: il ragazzino proveniente dal quartiere malfamato, con una buona dose di violenze familiari e vittima di bullismo da parte di coetanei o giù di lì che, spinto dalla disperazione, scala i ranghi sociali con qualsiasi mezzo possibile.
Attenzione, qui abbiamo un altro fatto imprescindibile. Seppur si possa provare un briciolo di umanità per una storia così drammatica agli albori, ciò non giustifica tutta la violenza che verrà dopo. Ma andiamo avanti.
Il documentario mostra un uomo che ha usato il potere come strumento di dominio, intimidazione e controllo.
Si parla di violenze fisiche e verbali, abusi sessuali, minacce di morte, abuso di sostanze stupefacenti, omicidi, sequestri di persona, detenzione di armi: un one man show. E “God bless the U.S.A.” per averlo idolatrato e reso multimilionario.
Un uomo che ha calpestato chiunque o qualsiasi cosa si ponesse tra lui ed il successo. E a quel punto il talento – seppur con una buona dose di complicità – diventa irrilevante.
Il talento non è una carta jolly.
Il successo non è un’assoluzione preventiva.
E soprattutto: essere capaci non rende meno spregevoli.
Il potere funziona perché qualcuno lo accetta
Qui arriviamo ad una parte che spesso fa storcere il naso, una parte delicata e complessa, quella che molti evitano per paura di essere accusati di victim blaming.
Ma evitare la complessità non rende il discorso più giusto, lo rende solo più comodo.
Come vi dicevo, mente vediamo sto Puff Daddy che minaccia, picchia e stupra, osserviamo anche le testimonianze.
Le testimonianze, commoventi, delle vittime di Diddy.
Le persone coraggiose che si sono fatte avanti e hanno deciso di denunciare.
Ed è proprio qui che è iniziato a scattarmi qualcosa: mentre osservavo ed ascoltavo il loro punto di vista sulle vicende delle violenze subite, son giunto a questa conclusione: il potere non è mai un monologo. È una relazione.
E ogni relazione di potere esiste perché qualcuno, spesso in silenzio, spesso per disperazione, spesso per convenienza, spesso per ambizione, accetta di farne parte.
Questo non significa che chi subisce violenza se la meriti. Significa che il sistema che permette quella violenza è collettivo.
Ambizione, silenzi e compromessi
Il documentario è pieno di segnali ignorati, di comportamenti normalizzati, di dinamiche tossiche e molto violente accettate come “parte del gioco” e più di qualche volta anche in modo consapevole. Perché quando in ballo c’è il successo, la carriera, la visibilità, la gloria, la fama, la morale diventa improvvisamente flessibile e può andare tranquillamente a farsi benedire.
Si resta, si tace.
Si giustifica e ci si volta dall’altro lato.
Non perché sia giusto, ma perché conviene.
E Puff Daddy ha prosperato esattamente in questo spazio: una zona grigia fatta di paura, idolatria e desiderio di appartenere al cerchio giusto. Di appartenere al “mondo che conta”.
Complicità non è colpa, ma non è neanche innocenza
È qui che il discorso si fa scomodo.
Riconoscere una complicità sistemica non significa assolvere l’abusante, ma nemmeno fingere che tutto accada nel vuoto.
La violenza resta violenza.
Ma prospera dove trova terreno fertile.
Ignorare questo significa continuare a raccontare storie comode: il mostro isolato, il genio maledetto, l’eccezione. Quando invece Puff Daddy e/o Aean Combs è l’esempio perfetto di ciò che succede quando il potere non viene mai messo in discussione. E, aggiungerei, al giorno d’oggi di esempi simili ce ne sono a bizzeffe.
Il problema non è Puff Daddy. È ciò che lo ha reso possibile.
Puff Daddy fa schifo. Per quello che emerge dal documentario, come persona, come figura di potere, come simbolo di un sistema malato. Ma fermarsi a lui è rassicurante. Significa non guardare oltre.
Questo meccanismo mi fa tornare in mente una famosa citazione di Tony Montana (Scarface), durante una cena non andata troppo bene per il gangster interpretato da Al Pacino. Lui dice:
“…vi serve la gente come me, così potete puntare il vostro dito del ca**o e dire: quello è un uomo cattivo.”
Quindi, alla luce di tutto ciò, mi sorge un quesito che sicuramente risulta molto meno comodo: quanto siamo disposti a tollerare, giustificare o ignorare pur di raggiungere il successo?
Se non sappiamo rispondere a questa domanda, probabilmente Puff Daddy non sarà un’eccezione. Resterà solo uno dei tanti.
Potrebbe interessarti anche:
Pax Massilia, il crime francese che divide e conquista
Ballard: il futuro del Bosch-verse ha un volto nuovo
Codici, crimini e coraggio: il fascino silenzioso di “The Bletchley Circle”
Unisciti a Zetatielle Magazine su Linktr.ee e ascoltaci su RID968.
Questo file è rilasciato con licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale . Autore Nicolas Richoffer