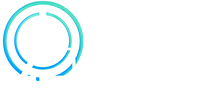La tragedia di Verona che ha visto la morte di tre carabinieri nell’esplosione del casolare di Castel D’Azzano, poteva essere evitata? Editoriale di Tina Rossi
Purtroppo, ci ritroviamo, ancora una volta, a commentare l’ennesimo tragico fatto di cronaca, che – con ogni probabilità – si poteva evitare. E saranno anche espressioni abusate, ma non posso esimermi dallo scrivere che ci troviamo di fronte ad una tragedia annunciata, divenuta tale forse soltanto per una catena di imprudenze e una sottovalutazione di segnali fin troppo evidenti.
Ma, prima di tutto, voglio esprimere a nome mio, del Direttore e di tutta la redazione di Zetatielle Magazine la nostra vicinanza all’Arma dei Carabinieri ed un sentito abbraccio alle famiglie dei militari deceduti e feriti.
Il mio però è un commosso e molto “arrabbiato” omaggio perché, ancora una volta, siamo costretti a commentare l’insensato gesto di un folle – o, come in questo caso, di più folli – che hanno compiuto una strage. Ancora una volta, la società civile non ha visto, o non ha voluto vedere o non è stata in grado di comprendere, e gestire, il disagio psicologico o, peggio ancora, riconoscere la follia.
Potrà sembrare fuori luogo, in un momento tanto doloroso, chiamare in causa le responsabilità di un “sistema” che – ancora una volta – ha fallito nel suo compito primario: proteggere la collettività e chi è chiamato a difenderla.
Ed è proprio questo il punto, ma andiamo con ordine.
Casal de’ pazzi
A Castel d’Azzano, alle porte di Verona, tre carabinieri hanno perso la vita durante un intervento in un’abitazione in stato di sfratto. Insieme a loro sono rimaste ferite, fortunatamente in forma lieve, altre 13 persone su 25, appartenenti all’Arma e ai Vigili del fuoco.
Sono entrati in una casa di campagna per eseguire un’operazione di perquisizione, unitamente allo sgombero dell’immobile, a séguito ad una situazione recidiva di resistenza alle Autorità da parte della famiglia oggetto del provvedimento di sfratto, e si sono trovati nel mezzo di una trappola esplosiva.
Un lampo, un boato, e in pochi secondi è letteralmente esplosa una tragedia.
È accaduto tutto in un contesto che, come spesso succede, appariva marginale: una proprietà agricola contesa, tre fratelli che da anni vivevano un conflitto economico e personale, un provvedimento di sgombero che doveva soltanto chiudere una vicenda. Ma dietro quel casolare di campagna c’era molto di più. C’era una storia di isolamento, di rabbia sedimentata, di incomunicabilità con il mondo esterno. E soprattutto, c’era il segno di un disagio profondo che molti avevano intercettato ma che nessuno aveva denunciato.
Le cronache si sono concentrate sui nomi dei carabinieri, sui profili delle vittime e sulla dinamica dell’episodio. È giusto, è doveroso.
Ma resta una domanda che rimbalza, cupa, in questi giorni: com’è possibile che tutto questo accada in un Paese che si definisce civile, in una zona dove le istituzioni, i vicini, i servizi dovrebbero essere presenti? Com’è possibile che una famiglia, con alle spalle una vita di lavoro nei campi e una storia di difficoltà economiche, arrivino a pianificare un gesto di distruzione così estremo, senza che nessuno percepisca il rischio?
Cronaca di una morte annunciata
Non è la prima volta che una tragedia si consuma ai margini di una procedura amministrativa. Dietro ogni sfratto, dietro ogni pignoramento, ci sono vite intere che si sfaldano, spesso in silenzio. Ma la vicenda di Verona ha una portata diversa, perché rivela il fallimento collettivo di un sistema di attenzione e di relazione. Non si tratta soltanto di una “follia improvvisa”, come qualcuno ha liquidato. È il prodotto di una serie di mancanze: relazionali, istituzionali, comunitarie. Un’assenza di reti sociali e istituzioni che non hanno comunicato e interagito tra loro.
Era noto che i fratelli avessero manifestato pubblicamente segni di squilibrio in diverse occasioni, prova ne sono le testimonianze dei vicini che riferiscono di abitudini insolite, come quello di uscire solo di notte pur essendo contadini e allevatori, di vivere senza elettricità, pur avendo un intero casolare.
Era noto, che i Fratelli Ramponi avessero delle gravi pendenze giudiziarie nei confronti della banca erogatrice di un mutuo sulla loro proprietà, ricevuta in eredità con altri possedimenti.
Ma soprattutto era noto il loro comportamento minaccioso e la loro spericolata determinazione nel difendere la loro proprietà. Non era la prima volta che mettevano in atto gesti insensati: in occasione della vendita all’asta della loro casa, uno di loro era salito sul tetto del tribunale minacciando di buttarsi nel vuoto, mentre la sorella si era cosparsa di benzina davanti alle autorità.
E allora la domanda sorge spontanea: la morte dei tre carabinieri è stato solo l’esito di una tragedia imprevedibile, o la cronaca di una morte annunciata?
Quando un disagio si trasforma in ostilità verso tutto e tutti, significa che la persona ha smesso da tempo di sentirsi parte della comunità. E che la comunità, probabilmente, aveva già smesso di vederla.
C’è qualcosa di profondamente simbolico in questa esplosione: la casa che diventa una trappola, il luogo domestico che si rovescia in campo di battaglia. È la rappresentazione più amara di un Paese dove la solitudine sociale non fa rumore finché non deflagra. In quelle mura, chiuse e dimenticate, si è consumata una sconfitta che non riguarda soltanto le vittime o i colpevoli, ma tutti noi. Perché ogni volta che un’esistenza scivola fuori dal radar del senso comune, ogni volta che la disperazione trova spazio nel silenzio generale, significa che la comunità ha perso la sua funzione più elementare.
A Verona è esplosa una casa, ma il boato ha colpito molto più lontano. Ha raggiunto ogni città dove qualcuno vive in bilico, ogni ufficio comunale che riceve segnalazioni in ritardo, ogni quartiere dove la povertà viene chiamata “problema degli altri”. È da qui che occorre ripartire: dal riconoscere che non è solo una storia di cronaca nera, ma un sintomo di qualcosa che ci riguarda da vicino. Perché dietro l’orrore e la morte ci sono domande che, se continuiamo a eludere, continueranno a tornare.
Storie di ordinaria follia
Ogni volta che accade una tragedia come quella di Verona, il dibattito pubblico si riempie di parole come “follia”, “gesto inspiegabile”, “dramma della disperazione”. Sono parole che rassicurano, perché ci allontanano. Servono a dire che quello che è successo non potrebbe capitare a noi, ai nostri vicini, al nostro quartiere. È un modo per confinare l’orrore in una zona separata della realtà, dove tutto è eccezione, tutto è irripetibile. E invece no: dietro la superficie dell’“imprevedibile” c’è quasi sempre una storia prevedibile, solo non vista. Perché la società di oggi, prima di essere orribilmente indifferente, è distratta, salvo poi nutrirsi famelicamente di queste notizie come Saturno nel quadro di Goya. E la distrazione, quando si parla di fragilità umane, può essere letale.
L’indifferenza di cui parliamo non è quella brutale, fatta di cinismo o disprezzo, è più sottile, più quotidiana. È la somma di mille piccoli gesti mancati: la porta che non si bussa, la domanda che non si fa, la curiosità che si spegne per paura di essere coinvolti. È il vicino che “non vuole problemi” ma che spia dietro le tende, l’amministratore che “non può farci niente”, il politico locale che “non ha competenze dirette”. Una catena di omissioni che inizia in basso, nelle relazioni umane, e finisce in alto, nei palazzi dove tutto si perde nelle pieghe della burocrazia, per competenze e limiti. Tutti, a loro modo, si limitano a guardare da lontano. E nel frattempo le persone più fragili scivolano in una zona d’ombra dove nessuno le vede più.
La società dell’inclusione
Chi vive un disagio economico o psicologico tende a isolarsi, a chiudersi. È un meccanismo di difesa, ma anche una richiesta di aiuto mascherata. L’errore collettivo sta nel credere che basti “lasciare spazio” per rispettare la libertà dell’altro. In realtà, spesso quel rispetto apparente è una forma di abbandono. La società contemporanea si riempie di discorsi sull’inclusione, ma pratica quotidianamente la distanza. Ci diciamo solidali, ma evitiamo il contatto. In un tempo in cui la connessione digitale è permanente, la connessione umana è diventata episodica, intermittente, incerta.
Ma, si sa, il disagio, quando non trova ascolto, si incattivisce. Prima diventa sospetto, poi rancore, infine ostilità. Ed è in quel passaggio, silenzioso e quasi invisibile, che le storie si deformano. Nessuno nasce ostile, nessuno nasce pericoloso. Ma chi non si sente più riconosciuto, chi percepisce il mondo come un nemico, comincia a vivere come se fosse già escluso da tutto. E quando la disperazione coincide con la perdita di fiducia, il passo verso l’irreparabile può essere corto. A quel punto, parlare di “tragedia imprevedibile” serve solo a nascondere il fallimento collettivo di un sistema che non sa più guardare.
Attenzione: non sto giustificando il gesto degli assassini di Verona, né sto trovando una difesa plausibile per sminuire il loro crimine. Sto solo considerando da un punto di vista analitico l’origine della deviazione mentale che porta alcuni esseri umani ad agire con estrema follia e del contesto sociale che lo rende possibile.
Eppure, queste persone non vivevano in un luogo sperduto, lontano dal mondo.
Questa storia non arriva da un casolare isolato in qualche remota valle dell’Appennino – aree spesso disabitate e fuori dalla portata di un vigile controllo delle autorità – ma si è consumata nelle campagne del produttivo Nord-Ovest, in un comune di 12.000 abitanti.
Una tragedia, quella di Verona, per nulla lontano dagli occhi di tanti. Eppure, comunque invisibile.
Le periferie sociali – che non sempre sono geografiche – sono piene di vite che non trovano un interlocutore. Anziani soli, piccoli imprenditori schiacciati dai debiti, persone che convivono con fragilità mentali, famiglie che non riescono più a sostenere il peso delle bollette o degli affitti. Sono storie che non finiscono sui giornali finché non diventano cronaca nera. Eppure, il loro silenzio è già un urlo. L’indifferenza, oggi, non è un sentimento: è una condizione strutturale, quasi un’abitudine culturale. Finché non impareremo a riconoscerla come tale, continueremo a sorprenderci davanti alle conseguenze, fingendo che siano eccezioni.
Domande scomode
Eppure, direte voi, il nostro sistema sociale è ben strutturato tra sussidi e assistenze. Certamente, ma è un sistema che va messo in moto, non ha vita propria e non agisce autonomamente. I primi commenti che ho raccolto sono un ottimo spunto di riflessione sul mancato intervento di servizi sociali a supporto e sostegno di una famiglia come quella di Verona. Vero. Ma in questo specifico caso, se non sono intervenuti, probabilmente è perché non sono stati chiamati. Quando non ci sono segnalazioni né denunce – che non devono necessariamente arrivare dalla famiglia interessata, ma che possono essere fatte da privati cittadini e autorità – l’intervento sarebbe un abuso di cui nessun professionista vorrebbe farsi carico. Ci deve essere sempre una richiesta della persona o dell’autorità giudiziaria, altrimenti nessun operatore sociale viene a bussare alla porta.
Qualcuno aveva richiesto un TSO o quanto meno valutato l’opportunità di un intervento o segnalato il fatto, quando uno dei fratelli era andato sul tetto del tribunale o la sorella si era cosparsa di benzina?
Quando i droni delle forze dell’ordine, diversi giorni prima della strage, hanno sorvolato la casa e individuato bombe molotov sul tetto, che criteri hanno usato per valutare la pericolosità della situazione per l’intera comunità?
Purtroppo, in buona fede, non hanno saputo leggere la sofferenza, il disagio profondo e soprattutto l’angoscia ed il tormento di persone del tutto scollegate dal contesto sociale, immerse in una povertà estrema, in un isolamento totale che genera quella rabbia disperata e incontrollabile di chi non ha più nulla da perdere. Un sentimento estremo, quello del “non avere nulla da perdere”, che rappresenta forse il più pericoloso detonatore di violenza sociale, in ogni tempo e in ogni luogo.
I caduti di Verona
Considerata l’affermazione del Comandante dei Carabinieri “non abbiamo così tante perdite da Nassiriya”, spero di non leggere che questa vicenda sia paragonabile a Nassirya, perché mancano i termini di paragone. Nassirya era tutt’altro contesto storico e politico.
L’intervento dei carabinieri a Castel d’Azzano rientrava nella prassi consolidata per gli sfratti giudiziari: l’ufficiale giudiziario, incaricato di eseguire l’atto, viene sempre accompagnato da personale delle forze dell’ordine quando esiste anche solo il rischio che la persona coinvolta opponga resistenza o reagisca in modo violento. Non si tratta di un eccesso, né di una militarizzazione dell’atto: è una misura di sicurezza necessaria, prevista dalla legge, che tutela l’incolumità degli operatori e garantisce l’esecuzione regolare degli atti giudiziari.
In questo specifico caso, ovviamente, si è ricorso a un impiego massiccio delle forze dell’ordine visto i precedenti sopralluoghi che confermavano la presenza di bombole del gas e molotov e, stando alle dichiarazioni riportate su Il Fatto Quotidiano, sul posto erano presenti i carabinieri dei Reparti speciali e gli agenti dell’Uopi (Unità Operative di Primo Intervento), specializzati in azione antiterrorismo. Se ciò corrisponde al vero, purtroppo, siamo di fronte ad un incidente che rientra nei rischi previsti dalle mansioni specifiche della professione, senza nulla togliere alla drammaticità della tragedia, più che mai premeditata e che merita di essere punita in maniera esemplare. “Stiamo valutando se effettivamente c’è strage – ha affermato Raffaele Tito, procuratore di Verona – valuteranno i carabinieri, sicuramente è un omicidio premeditato e volontario“. Pienamente d’accordo.
Nei secoli fedele
Ogni carabiniere sa che la sua presenza serve a prevenire incidenti, non a provocare conflitti. Quello che invece non poteva essere previsto con altrettanta certezza era il livello di disperazione e di rabbia accumulata dai fratelli coinvolti, né la decisione di trasformare la casa in una trappola mortale.
Ed è qui che emerge il nodo più grave: il fallimento della rete di protezione sociale che avrebbe potuto intercettare il disagio molto prima che degenerasse.
L’atto delle forze dell’ordine era corretto, la procedura rispettata, ma la tragedia non si poteva evitare senza una comunità vigile, consapevole e pronta ad intervenire.
La tragedia di Verona non è un fatto isolato né un caso che possiamo archiviare come “eccezione”. Non possiamo limitarci a contare le vittime e a fare cronaca della dinamica: dobbiamo riconoscere che ogni evento come questo è anche il riflesso della società in cui viviamo, delle relazioni che si spezzano, delle reti di protezione che non funzionano.
Non ci sono colpe uniche, eppure ci sono responsabilità diffuse. La comunità, i vicini, le istituzioni, le autorità locali e perfino noi stessi, come cittadini, condividiamo un pezzo di questa storia.
Guardare oltre l’esplosione e le vittime significa assumersi la responsabilità di vedere prima che sia troppo tardi. Significa trasformare l’indifferenza in attenzione, il silenzio in dialogo, la distanza in vicinanza. Solo così tragedie come quella di Verona possono diventare strumenti di consapevolezza, non semplici titoli di cronaca.
Foto copertina di djedj da Pixabay
Potrebbe interessarti anche:
Garlasco: e se fosse un errore giudiziario, chi paga?
Delitto Afragola: crescere troppo in fretta è un’emergenza culturale e sociale
Gli italiani in guerra? Come in amore, c’è chi combatte e chi fugge