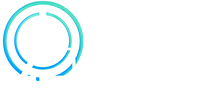Crans Montana raccontata attraverso i comportamenti di una generazione iperconnessa. Che cosa spinge a filmare piuttosto che a scappare? Editoriale di Tina Rossi
Nel cuore della tragedia che ha sconvolto Crans Montana nella notte di Capodanno, in quel terribile incendio devastante che ha raso al suolo il locale Le Costellation e causato 40 vittime e oltre 100 feriti di cui moltissimi in gravi condizioni, si è consumata un’altra tragedia invisibile, di differente ma forse non inferiore gravità.
Una tragedia dell’epoca digitale che origina da una delle derive culturali che è divenuta devianza sociale e che, troppo spesso, viene denunciata ma, poi, nei fatti totalmente ignorata. Mi riferisco al comportamento di molti degli sfortunati ragazzi, che ancora una volta hanno dimostrato di essere così ossessionati dal mondo virtuale da essere totalmente dissociati e disconnessi da quello reale.
Così mentre un locale brucia e milioni di anni di istinto ti urlano di scappare, anche se hai 15 o 16 anni, la tecnologia si interpone tra te e la coscienza di te stesso e, di istinto, ecco che la reazione immediata non è quella di mettersi in salvo ma di prendere il telefono e realizzare video, spinti dall’ossessione compulsiva di “fermare il momento” o dall’abitudine di vivere tutto mediato dallo schermo. E forse non più solamente per poi avere qualche secondo di attenzione e di condivisione con quelli che – di fatto – sono degli assoluti estranei.
So che cosa state pensando:
come si fa a scrivere certe cose con 40 morti dei quali molti sono minorenni?
Sì, può sembrare fuori luogo, e anche difficile, perché irrita la sensibilità di tutti ma, onestamente è un pensiero che molti – più di quanti pensiamo – hanno avuto e alcuni hanno anche avuto il coraggio di esprimerlo. Ma, alle volte, è opportuno sgomentare per ottenere la giusta attenzione e ricordare una verità scomoda, in un momento del genere, può essere un modo efficace per scuotere i nostri intorpiditi cervelli.
Quindi, eccomi qui a parlare di verità scomode, anche per evitare di perdermi anch’io dietro quella dilagate retorica che vuole descrivere questi morti e le loro storie, come più importanti di quelle di altri, perché oggi vengono raccontate diversamente – giusto per fare un esempio – da come vengono riportati i numeri (perché di fatto sono solo numeri per molti di noi) che ogni giorno vengono aggiunti all’infinita lista dei morti in Ucraina. Ma lì – per l’opinione pubblica ed i colleghi giornalisti – è “normale” morire: c’è la guerra. Lì i morti sono così lontani da noi, da non avere neppure un nome né una vita fatta di parenti e sogni. E poi sono stranieri… ma la questione morale del nazionalismo “giusto” e di quello “sbagliato” parleremo in altra occasione.
Non ci sono morti eccellenti
Sì, lo devo ammettere: mi infastidisce molto osservare chi va oltre al diritto di cronaca e fa show-business su questi morti, anche se è oramai divenuta una prassi così consolidata da farne passare sottotraccia la disgustosa retorica che dietro vi si nasconde: sì, perché questi morti, per quanto la notizia sia scioccante e la tragedia toccante, non sono più importanti di alcuno degli oltre 1.750 italiani che ci lasciano ogni giorno.
Tanti sono anziani (e purtroppo ad un certo punto della vita arriva necessariamente quel momento), molti sono purtroppo malati (e purtroppo ci si ammala, anche se questo non è il pensiero di chi si ammala) ma tanti, tantissimi muoiono per incidenti sul lavoro oppure in automobile, e soprattutto circa 6 (sì 6 ogni giorno) sono minorenni, tutti con storie analoghe a quelle che ora occupano le pagine dei quotidiani, le anteprime e gli approfondimenti dei telegiornali ed i vari talkshow che speculano sull’argomento.
Dove abbiamo sbagliato?
Non fraintendete, sono madre ed ho pianto al pensiero di questi sfortunati ragazzi che non ci sono più e forse provo ancor più dolore per tutti i feriti che hanno iniziato un calvario fatto di sofferenze fisiche inimmaginabili e di sofferenze psicologiche difficilmente superabili, o forse insuperabili. Piango pensando allo strazio di genitori, dei fratelli e sorelle e di tutti componenti delle famiglie coinvolte, perché queste sono tragedie immense e, per molti, senza fine.
Ma, da madre, non posso non pensare: dove abbiamo sbagliato? Come abbiamo potuto crescere dei figli talmente iperprotetti da essere totalmente ignari e incapaci di affrontare i pericoli del mondo?
Come siamo riusciti in poche generazioni a cancellare persino il lavoro di millenni di madre natura per sviluppare l’istinto di sopravvivenza?
Com’è possibile che, mentre le fiamme avvolgevano l’edificio e il panico dilagava tra chi cercava di mettersi in salvo, molti hanno alzato i telefoni, registrando ogni dettaglio, ogni urlo, ogni fuga, come se la priorità fosse produrre un documento visivo del dramma piuttosto che cercare di salvarsi la vita o prestare aiuto. Com’è possibile che ciò accada sempre più spesso?
Siamo tutti in un reality show
La psicologia sociale e le ricerche recenti mostrano come oggi, di fronte a situazioni di emergenza, le persone non reagiscono più come avveniva in passato, con un’azione immediata, ma sembrano vivere in una realtà parallela, mediata dalla tecnologia, dove l’atto di riprendere diventa quasi una reazione automatica. Ma cos’è che spinge le persone, in particolare i giovani, a filmare la morte, il caos, il disastro, invece di provare a fermarlo o a intervenire concretamente?
Quali meccanismi psicologici, sociali e culturali trasformano la realtà in un film, la responsabilità in un gesto di documentazione, e l’urgenza in contenuto digitale?
Questa reazione, purtroppo, non è un’eccezione isolata. Gli psicologi sociali chiamano questo fenomeno effetto spettatore, una dinamica studiata da John Darley e Bibb Latané negli anni Sessanta, secondo la quale la presenza di più testimoni riduce la probabilità che qualcuno agisca, perché ciascuno tende a delegare implicitamente la responsabilità agli altri.
Nel contesto dell’incendio di Crans Montana, lo smartphone non ha fatto che amplificare questo meccanismo: filmare sostituisce l’azione, osservare attraverso uno schermo crea una distanza emotiva e fisica dall’urgenza reale, mentre la registrazione diventa la prova simbolica della propria presenza e attenzione.
C’è di più: guardare la tragedia attraverso un monitor trasforma l’attore in spettatore, cioè, trascina mentalmente la persona in una sorta di dimensione parallela che la trasporta virtualmente sul divano di casa, genera una sensazione di confort emotivo e di sicurezza del luogo protetto che, come in un film o in un videogioco, non può dunque ferirla.
La narrazione dell’orrore e la sua percezione
Sherry Turkle, sociologa, psicologa e tecnologa statunitense, ha descritto come nella società digitale l’esperienza umana si trasformi in identità mediata, dove la priorità non è vivere l’evento ma documentarlo, renderlo visibile, confermarne la propria presenza. Nel caos delle fiamme e del fumo, i giovani che filmavano non cercavano necessariamente fama o approvazione sociale immediata, ma rispondevano a un bisogno più profondo: controllare ciò che è incontrollabile, trasformare il trauma in un oggetto osservabile, ridurre l’angoscia e l’impotenza attraverso la registrazione.
L’incendio diventa così il contenuto, il pericolo un soggetto narrativo e la paura un materiale da condividere, mentre la realtà concreta – persone intrappolate, urla, fumo soffocante – viene mediata, filtrata e resa tollerabile dallo schermo del telefono.
Sherry Turkle, inoltre, ha sottolineato come nella società digitale l’identità dell’individuo si costruisca sempre più attraverso la visibilità e la documentazione. Il gesto di riprendere non nasce necessariamente dalla voglia di notorietà, ma dalla necessità di certificare la propria presenza, di produrre una traccia tangibile del proprio rapporto con la realtà. La videocamera diventa così un’estensione del corpo, uno strumento attraverso il quale il mondo si rende leggibile e “controllabile” senza richiedere interazione diretta. L’incendio, la paura e il dolore non devono essere vissuti pienamente: basta registrarli.
Erving Goffman aveva già sottolineato che il comportamento umano si modula secondo la percezione dell’altro, creando una sorta di “schermo sociale”. Oggi, lo schermo fisico dello smartphone ha sostituito in gran parte quello metaforico: osservare, registrare e condividere diventano atti di partecipazione, che sembrano implicare presenza e coinvolgimento, ma neutralizzano la responsabilità concreta, generando una sorta di disconnessione emotiva. La distanza emotiva diventa meccanismo di sopravvivenza psicologica, ma al contempo genera una perversione sociale, perché la priorità diventa la documentazione della tragedia anziché la reazione attiva ad essa.
La sindrome del “io c’ero”
Questa dinamica si manifesta in molti altri contesti della vita contemporanea: concerti, stadi, piazze affollate, dove la compulsione a riprendere tutto impedisce di vivere direttamente l’esperienza e trasforma ogni evento in contenuto da osservare e archiviare. La tecnologia, in questo senso, non aumenta soltanto la capacità di comunicare, ma produce una dipendenza comportamentale, una mutazione della percezione della realtà, dove la responsabilità personale e la reazione immediata cedono il passo alla registrazione compulsiva.
Il comportamento di filmare invece di intervenire non è solo una questione morale o educativa; è il sintomo di una trasformazione collettiva, una devianza che riflette la struttura sociale contemporanea. La selezione mediatica dei contenuti, la cultura della visibilità e la viralità hanno reso la ripresa digitale non un’opzione, ma una reazione quasi automatica, che sostituisce la percezione diretta con la rappresentazione, la partecipazione concreta con la prova simbolica del “io c’ero”. La tragedia svizzera ci mostra in forma estrema ciò che ormai caratterizza la vita quotidiana: il mondo viene vissuto attraverso un filtro, e la distanza emotiva e fisica diventa la norma.
Voyeur
Questa trasformazione ha conseguenze profonde sul piano sociale. La responsabilità collettiva si dissolve, il senso di urgenza si riduce a una sequenza di immagini e il trauma reale viene mediato e reso consumabile. La ripresa continua, talvolta ossessiva, di eventi tragici mostra una vera e propria perversione della percezione sociale: ciò che conta non è più intervenire o prevenire, ma documentare, produrre, mostrare. Il disastro diventa contenuto, il dolore diventa materiale visivo, la vita altrui un soggetto narrativo da osservare, condividere e catalogare.
Anche la ricerca più recente sul comportamento collettivo indica che non esiste un unico determinante: il contesto urbano, la presenza di altri, la norma sociale percepita, l’uso del telefono e la saturazione dell’informazione creano insieme un ambiente in cui l’azione diretta è raramente la scelta immediata. In questo senso, la tragedia svizzera è paradigmatica: la combinazione di folla, emergenza e tecnologia ha prodotto un comportamento che non è la semplice somma di individualità, ma un fenomeno collettivo strutturale, dove la compulsione a filmare sostituisce la reazione diretta.
Le implicazioni di questo fenomeno sono profonde e inquietanti. La società si trova davanti a una mutazione della percezione della realtà, complici, negli ultimi vent’anni, i social network.
Il quarto d’ora di Andy Warhol
Infatti, il mondo virtuale dei social offre una vetrina dove la teoria di Warhol trova il suo più sublime riscontro empirico: il paradisiaco spazio web accoglie molti più pretendenti di quanto non ne abbia la vecchia cara televisione, e pur di godere di quel famoso quarto d’ora di celebrità, le persone sono disposte a fare qualsiasi cosa. I social hanno dato l’idea di una realtà sociale aumentata, che va oltre il cerchio dell’ambiente individuale, che poi è diventata una necessità. La gente non può più pensare di essere importante per 5 o 6 amici e pochi famigliari, ma ha l’esigenza di avere una interazione allargata che solo i social, che l’hanno generata, possono garantire.
E così, ciò che richiede intervento immediato, viene al contrario percepito come un’occasione per trasformarsi in attori e registi di una scena che, con un po’ di fortuna, può diventare virale sulla piattaforma preferita e, perché no, dare quella fama e visibilità tanto anelata e contesa dalla società voyeurista. E così, la tragedia, il dolore, il rischio diventano un contenuto, e la responsabilità collettiva si dissolve nella compulsione a documentare. L’atto stesso di filmare genera una gratificazione, sia per l’attenzione ricevuta, sia per il senso di controllo che produce, consolidando un comportamento che, in assenza di consapevolezza critica, si ripete e si diffonde.
Siamo lo specchio del tempo che viviamo
Inoltre, la cultura digitale ha trasformato le priorità sociali. La selezione delle informazioni, la viralità dei contenuti – reel e post – e la spettacolarizzazione delle tragedie hanno reso la visibilità un valore centrale, spesso più importante della risposta concreta. La morte, il pericolo, l’emergenza diventano eventi narrabili, osservabili, condivisibili, ma raramente “interagibili” nel senso tradizionale. Questa logica si collega alle devianze sociali moderne: la normalizzazione di comportamenti passivi, ma altamente performativi, altera la percezione collettiva della responsabilità e del rischio.
Il fenomeno non è inevitabile, ma richiede un’analisi critica della società contemporanea e della tecnologia che la pérmea. Non si tratta solo di fare della morale, ma di comprendere sia le dinamiche che spingono i giovani a filmare invece di intervenire, sia la centralità del dispositivo digitale nel filtrare la realtà e la trasformazione dei comportamenti collettivi.
E questo comportamento che si è ripetuto a Crans Montana, non è un fatto drammatico isolato, ma lo specchio di un fenomeno molto più ampio. La tecnologia ha trasformato la percezione della realtà, la responsabilità individuale e collettiva e il modo in cui affrontiamo il dolore e la sofferenza altrui, e ha generato una abitudine collettiva a considerare sufficiente la testimonianza visiva, come se vedere e mostrare potessero assolvere dal dovere di intervenire e, addirittura, dall’istinto di vivere la realtà. È in questo scarto, sempre più normalizzato, che si misura oggi una delle forme più silenziose e pervasive di impoverimento del legame sociale.
Potrebbe interessarti anche:
Il caso della famiglia che vive nel bosco: vittima o carnefice?
Tragedia di Verona: cronaca di una morte annunciata?
Garlasco: e se fosse un errore giudiziario, chi paga?
Miss Finlandia perde la fascia e la faccia per un…cinese!
Foto copertina: file rilasciato con licenza Creative Commons Attribuzione 2.0 Generica originariamente pubblicata su Flickr da Paolo Gamba