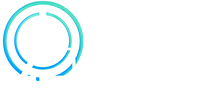Approvato il nuovo Decreto Sicurezza 2026: inasprimenti delle pene, paradossi e overload normativo. Era proprio necessario?
Così come vuole la tradizione, con l’arrivo dell’anno nuovo si rinnovano i buoni propositi! Ma poi, lo sappiamo bene tutti che “di buone intenzioni è lastricata la via dell’inferno.”
Il “Decreto Sicurezza 2026″ appena promulgato che, per dichiarazione del governo, è stato emanato in attesa di un prossimo disegno legge che porterà modifiche più sostanziali alle leggi in materia, prevede l’ennesimo inasprimento sia delle misure preventive che delle pene di alcuni reati ma, soprattutto, comporta maggiori oneri per le forze dell’ordine che però opereranno con strumenti sempre meno efficaci e con poteri sempre più de-limitati, tanto che viene spontaneo chiedersi se poi qualcuno in galera ci andrà veramente… e soprattutto per quanto tempo.
Ma andiamo con ordine!
Ma era proprio necessario un Decreto Sicurezza 2026 ?
È assolutamente corretto e opportuno – anzi doveroso per qualsiasi governo – adeguare le leggi alla costante evoluzione della società o intervenire su di esse per gestire criticità contingenti o emergenti, ma nel caso del decreto sicurezza 2026, mentre alcuni perseguono una maggiore severità da parte dello Stato, c’è chi invece invoca – con disarmante superficialità – più poliziotti (ovviamente disarmati, da rendere facili bersagli della delinquenza dilagante) e, purtroppo, solo in pochi si interrogano su che cosa non funzioni davvero nella filiera della giustizia, tanto da averle fatto perdere sia gran parte dell’efficacia punitiva che qualsiasi valore di deterrenza.
Questo decreto sembra attribuire maggiori poteri a chi deve garantire l’ordine pubblico ma, nella realtà, l’unico vero nuovo strumento – il fermo preventivo – sebbene limitato alle manifestazioni e, di fatto, ben circostanziato, per noi amanti della libertà, non suona per nulla bene. Anzi, proprio non ci piace!
Più “poteri” alle forze dell’ordine
Le forze dell’ordine ci sono sempre, oggi come in passato, e nessuno può in alcun modo sostenere che non facciano il loro dovere in maniera efficace o, quantomeno, adeguata alle risorse a loro disposizione. Magari, quando si tratta di investigare, non sono efficaci come quelle raccontate in CSI Miami, Vegas o New York, ma ci sono sempre e si impegnano ogni giorno per garantire la sicurezza di tutti noi. E, dallo scorso anno, il numero di agenti è stato implementato di 40.000 unità.
Però, a noi amanti della libertà, l’idea di dare più poteri alla polizia non piace, proprio in senso assoluto: Dio ci scampi dagli sceriffi a stelle e strisce! Ma anche qualora fosse necessario dar loro più poteri, la domanda che sorge spontanea è: ma se poi le forze dell’ordine questi poteri li esercitassero sul serio che cosa accadrebbe? Apriti cielo e soprattutto apriti inchiesta, anche se – ça va sans dire – solo ed esclusivamente come atto dovuto…
Forze dell’ordine: le parole sono importanti!
A costo di apparire presuntuosa, è opportuno, anzitutto, chiarire un aspetto di carattere terminologico perché come dice Nanni Moretti “Chi parla male, pensa male e vive male”.
Al di là delle superficialità storica delle letture ideologiche di taluni che, ottenebrati dal “fascismo”, vi ravvisano intenti di sopraffazione, l’espressione “forze dell’ordine” designa in modo molto preciso la funzione attribuita a tali istituzioni: garantire – in nome e per conto della collettività – l’ordine pubblico, anche ricorrendo alla forza. Perché l’ordine pubblico, in uno Stato di diritto, non è un concetto autoritario, bensì la condizione giuridica minima che rende possibile l’esercizio delle libertà individuali.
Pertanto, anche l’uso della forza non rappresenta un arbitrio, ma uno strumento legittimo, ovviamente solo se rigidamente regolato e sottoposto al principio di proporzionalità. Ed anche se esso costituisce l’extrema ratio, da impiegare solo quando tutti gli altri mezzi si sia rivelati inidonei, negare in radice che l’ordine possa, se necessario, essere mantenuto o ristabilito anche mediante la forza, significherebbe svuotare di contenuto la stessa funzione istituzionale affidata alle forze dell’ordine. Ed il fatto che esse siano armate non è un elemento meramente simbolico, bensì l’espressione concreta del mandato affidato loro dalla società stessa che, nei limiti stabiliti dalla legge, contempla anche l’uso delle armi quale strumento di tutela dell’incolumità collettiva.
In nome del popolo italiano
Abbiamo già detto che le forze dell’ordine, benché sembrino sempre troppo esigue nel numero, in realtà ci sono sempre e quando chiamate ad intervenire lo fanno con adeguatezza. Ma l’operato delle forze dell’ordine non può essere disgiunto dall’ordinamento giuridico in nome del quale operano, perché le leggi poste a presidio della società civile non sono meri enunciati formali, ma costituiscono l’architettura normativa che rende possibile una convivenza fondata su diritti e doveri reciproci, e senza ordine pubblico non vi è libertà, bensì arbitrio e, senza regole condivise, non vi è convivenza sociale ma conflitto permanente.
La realtà è che nella società contemporanea, quella dei diritti del singolo e basta, sì è affievolita – anche nelle menti del legislatore – la consapevolezza che, in uno Stato di diritto, l’interesse della collettività rappresenta il fondamento e il limite entro cui trovano riconoscimento e protezione le posizioni del singolo. Infatti, negli ultimi decenni si è registrato, purtroppo con una certa frequenza, una tendenza ad una produzione normativa astratta rispetto alla realtà sociale alla quale dovrebbe riferirsi.
La funzione del legislatore
Oggi il legislatore, e non solamente in Italia, anziché limitarsi a tradurre in forma giuridica compiuta esigenze effettivamente maturate nella collettività, come ai tempi delle corporazioni e dei partiti politici, quelli veri, sembra talvolta assumere un ruolo pedagogico o persino moralistico, proponendo discipline ispirate più a visioni ideologiche o programmatiche che a bisogni sociali consolidati.
In una concezione “corretta” dello Stato di diritto, la legge non è il luogo dell’autoaffermazione culturale del legislatore, ovvero del parlamento, ma lo strumento attraverso cui l’ordinamento recepisce, ordina e stabilizza le istanze portate ad esso dal corpo sociale. La norma efficace è quella che, pur nella sua generalità e astrattezza formale, trova radicamento in dinamiche reali, riconoscibili e condivise: diversamente, quando la produzione normativa si distacca eccessivamente dal contesto sociale, il rischio è di produrre norme inefficaci e vulnerabili sul piano costituzionale.
Non è casuale che negli ultimi decenni numerosi interventi legislativi, adottati con forte carica simbolica o sotto la pressione del dibattito mediatico, siano stati successivamente oggetto di declaratorie di illegittimità costituzionale. Ciò non significa certamente che ogni intervento innovativo sia improprio, ma evidenzia quanto una legislazione concepita in modo frettoloso, frammentario o ideologicamente orientato dalla “pressione” popolare possa entrare in tensione con i principi superiori dell’ordinamento.
Ingegneria informativa
La funzione del legislatore non dovrebbe essere quella di “anticipare” la società secondo modelli teorici astratti, né di sostituirsi al tessuto sociale nel definire ciò che è opportuno o moralmente desiderabile. Piuttosto, essa consiste nel dare forma normativa a esigenze effettive, nel comporre conflitti già emersi e nel garantire stabilità e prevedibilità ai rapporti giuridici. Una legge costruita “a tavolino”, priva di adeguato radicamento nella realtà e, forse, talvolta elaborata pure senza sufficiente competenza tecnica, rischia di trasformarsi in un esercizio di ingegneria normativa destinato a produrre più incertezza che ordine.
In tal senso, la qualità della legislazione non si misura nella sua densità ideologica o nella sua capacità di suscitare consenso immediato, bensì nella sua coerenza e nella sua compatibilità costituzionale e, soprattutto, nella sua effettiva rispondenza alle esigenze della collettività che pretende di disciplinare.
Eppure, il diritto lo abbiamo inventato noi
Per amor di verità, da un punto di vista storico-giuridico, il nostro sistema affonda le proprie radici nel diritto romano, già pienamente strutturato ed evoluto tre secoli prima di Cristo, anche se molto più antico. Tale matrice continua a permeare l’ordinamento italiano tanto nella struttura concettuale quanto nella tecnica normativa. Tuttavia, negli ultimi decenni, la produzione legislativa si è progressivamente appesantita e l’impianto originariamente asciutto e incisivo, fondato su formulazioni sintetiche e norme di carattere generale, ha progressivamente ceduto il passo a una proliferazione di distinzioni casistiche, specificazioni ridondanti e dettagli regolativi che quasi mai accrescono la certezza del diritto.
Questa ipertrofia normativa sembra talvolta riflettere una duplice tensione: da un lato, una crescente giurisdizionalizzazione del conflitto sociale e dall’altro la conseguente tendenza del legislatore a intervenire in modo sempre più frammentario e specifico su singole fattispecie, spesso sull’onda dell’emergenza o del consenso contingente. Il risultato è un sistema in cui la moltiplicazione delle norme e delle fattispecie non coincide con maggiore chiarezza ma al contrario attribuisce al ruolo interpretativo del giudice un peso sempre più significativo, rendendolo piu complicato e, di conseguenza, più fallibile.
La verità si ritrova sempre nella semplicità, mai nella confusione (Isaac Newton)
Fatta eccezione per i sistemi di Common Law, propri di Paesi quali Regno Unito, Stati Uniti e Australia, fondati su una diversa concezione della produzione e dell’evoluzione del diritto, il Diritto Romano – e, per derivazione, tutta la tradizione giuridica del mondo sviluppato – insegnava la forza della sintesi e la centralità dei principi, e quindi l’efficacia della norma generale.
Diversamente, l’eccesso di regolazione contemporaneo rischia di tradire una certa sfiducia nella capacità dei principi, di orientare l’interpretazione e, nella responsabilità dell’interprete, di applicarli con equilibrio. Ne consegue un ordinamento formalmente più dettagliato, ma sostanzialmente molto meno leggibile e sicuramente meno coerente: il terreno perfetto per l’azione degli Azzeccagarbugli e per le “sentenze choc” sempre più frequenti negli ultimi anni.
Ma allora, se in sostanza non si può accusare il nostro ordinamento giuridico di particolare inadeguatezza e se non si possono incolpare le forze dell’ordine per mancanza di efficacia, che cosa non funziona nella filiera?
Il sistema carcerario
Possiamo affermare, con un ristretto margine di smentita, che uno dei punti più critici del complesso del sistema giudiziario sia quello carcerario e ciò nonostante il continuo aumento delle pene e gli inasprimenti normativi. La questione non è più “chi va in galera”, come e perché ci va, ma se ci va. Perché, le strutture sono sovraffollate, quasi tutte fatiscenti e comunque strutturalmente inadeguate a garantire sia la sicurezza che le condizioni minime di dignità umana. Il risultato è un paradosso evidente: mentre il legislatore impone pene sempre più severe, la realtà delle carceri rende difficile alla magistratura applicarle in modo efficace e civile.
Questo squilibrio tra l’approccio nell’utilizzo, gli intenti, gli strumenti, la lentezza e l’indolenza cronica della magistratura produce conseguenze importanti sul sistema sociale e ripercussioni inquietanti per i singoli. Così, da un lato ci sono persone detenute in condizioni tanto degradanti e stressanti da generare una vera e propria emergenza suicidi, ed inefficienze e lungaggini processuali che trasformano l’attesa di giudizio in una sospensione indefinita dalla vita: dall’altro ci sono pene inadeguate e spesso non scontate, e quindi un effetto di deterrenza pressoché nullo. Le carceri italiane, anziché rappresentare uno strumento di rieducazione e di protezione della società, diventano luoghi di accumulo, frustrazione e smarrimento.
Guardare il dito e non la Luna
La gestione delle carceri evidenzia il paradosso del Decreto Sicurezza 2026 perchè la maggiore severità prevista dalla legge rischia di scontrarsi anche con la realtà concreta degli istituti penitenziari. Le misure detentive diventano formalmente più dure, ma nella pratica si scontrano con la carenza di spazi, personale e programmi di reinserimento. Così, mentre il legislatore decide pene più severe, il sistema penitenziario italiano continua a dimostrare l’incapacità strutturale dello Stato di garantire giustizia effettiva, trasformando la promessa di sicurezza in un surrogato simbolico, più che in un risultato reale.
In buona sostanza, le carceri raccontano meglio di ogni statistica il fallimento di un approccio punitivo astratto e scollegato dalla realtà: leggi più dure servono a poco se non esiste un sistema capace di applicarle davvero, con modalità che siano al contempo rispettose della dignità umana e realmente efficaci, sia sul piano punitivo che su quello della sicurezza sociale.
Il potere giudiziario
L’anello debole della filiera della giustizia sembrerebbe, quindi, non poter essere individuato nel dato normativo né esclusivamente nelle carenze strutturali dell’apparato penitenziario, ma piuttosto nella fase applicativa, ossia nell’esercizio della funzione giurisdizionale.
E se intervenire sulle carceri richiede “solamente” risorse economiche e tempi di realizzazione, intervenire sull’assetto e sul funzionamento della magistratura implica, invece, un ripensamento più profondo del significato di giustizia nella nostra società, ripensamento che, per divenire realtà presupporrebbe volontà politica, consenso sociale e un confronto non ideologico sul ruolo della giurisdizione in uno Stato di Diritto.
Quando si parla di “anello debole” non si intende evocare genericamente l’inefficienza del sistema giudiziario, né indulgere in facili accuse di inerzia cronica del sistema. Il riferimento è piuttosto al risultato concreto dell’azione giudiziaria: ovvero al rapporto tra numero di reati e numero di condanne effettive, alla proporzione tra gravità dei fatti e severità delle pene irrogate ed alla sempre maggiore distanza tra la previsione normativa e la sanzione concretamente applicata.
È un dato oggettivo che il progressivo sbilanciamento interpretativo nell’applicazione della legge, nel tentativo – talvolta lodevole – di rafforzare le garanzie dell’imputato, finisca per comprimere in misura eccessiva l’esigenza di tutela della vittima e dell’interesse collettivo alla sicurezza. Ed il principale rischio di tale sbilanciamento è che il processo, da strumento di accertamento della responsabilità e di composizione del conflitto, si trasformi in un esercizio di prevalente protezione dell’autore del reato, con conseguente indebolimento della percezione di giustizia sostanziale.
Non sempre il mal comune è mezzo gaudio
A conferma di quanto affermato, è sufficiente richiamare un solo dato, ma particolarmente significativo: nel nostro Paese la condanna media per omicidio volontario — si badi, condanna irrogata e non pena effettivamente scontata — si attesta intorno ai 12,4 anni (fonte Non sprecare), a fronte di una cornice edittale non inferiore ad anni 21 di reclusione (art. 575 Codice Penale), pena massima l’ergastolo (art. 576, 577 e 577 bis Codice Penale). E se a ciò si aggiungono gli ordinari meccanismi di riduzione della pena, i benefici connessi alla buona condotta ed i permessi premio, la durata effettiva della detenzione diminuisce pure.
Il divario tra previsione normativa e pena concretamente eseguita non è un dettaglio statistico, ma un elemento che incide direttamente e fortemente sulla percezione di proporzionalità e sulla funzione deterrente della pena stessa. Né può ritenersi rassicurante il confronto con altri ordinamenti, talvolta evocato per relativizzare il problema, perché non è affatto dirimente in quanto la valutazione dell’efficacia di un sistema penale deve misurarsi con il contesto sociale e istituzionale di riferimento, non con la mera graduatoria comparativa della severità. Il confronto con altri ordinamenti che, per ragioni storiche, dimensionali e sociali sono differenti dal nostro e per questa ragione adottano politiche sanzionatorie ancora meno incisive, non costituisce un argomento sufficiente per ritenere soddisfacente la nostra.
In materia di giustizia penale, il mal comune non rappresenta alcuna consolazione.
Chi ha paura della giustizia italiana?
Uno degli effetti più evidenti di tale squilibrio è l’indebolimento della funzione deterrente del diritto penale. La percezione diffusa che la sanzione o la pena siano incerte, dilazionate o significativamente ridotte nel tempo, incide inevitabilmente sulla capacità dell’ordinamento di prevenire comportamenti devianti.
Se la pena o la sanzione non è prevedibile nella sua effettiva applicazione, la norma perde parte della propria forza orientativa.
Tanto che negli anni abbiamo osservato il progressivo affermarsi della devianza culturale della tolleranza a tutti i costi, che ha portato ad orientare sempre più la giustizia penale nella direzione della mera tutela delle garanzie dell’imputato, e parallelamente – sul versante opposto e popolare – continuiamo a riscontrare principalmente un sentimento di rivalsa immediata, di vendetta del tipo “occhio per occhio, dente per dente” che stanno ulteriormente cambiando la percezione sociale della concetto di giustizia in senso esteso.
Ciò che è certo è che un sistema giuridico maturo non può fondarsi né sull’emotività vendicativa né su un garantismo disancorato dall’interesse collettivo alla sicurezza. Deve, piuttosto, mantenere un equilibrio tra diritti individuali, diritti collettivi e tutela dell’ordine giuridico.
La funzione della pena: punizione, deterrenza, rieducazione
Un’altra questione che deve tornare ad essere una certezza è il fatto che le finalità della detenzione non possono essere ricondotte all’unica dimensione rieducativa, come sempre più spesso si sente evocare. Infatti, esse si articolano, in termini sistematici, in due fini primari e in un fine ulteriore, di natura complementare e comunque secondaria. I fini primari sono, anzitutto, quello punitivo — ossia l’irrogazione di una sanzione proporzionata alla gravità del reato commesso — e quello deterrente, inteso sia come prevenzione speciale nell’impedire la recidiva del reo, sia come prevenzione generale, ovvero dissuadere la collettività dalla commissione di analoghi illeciti.
La pena, in questa prospettiva, costituisce la risposta dell’ordinamento alla violazione della norma e rappresenta il momento in cui lo Stato – in nome e per conto del popolo sovrano – riafferma la validità del patto sociale infranto. Sebbene non debba divenire vendetta, non può nemmeno essere ridotta a mera occasione pedagogica, perché è – e deve essere – l’espressione di una responsabilità accertata e di un debito del reo nei confronti della collettività e della vittima. Il fine rieducativo – pur costituzionalmente rilevante e imprescindibile – assume invece una funzione ulteriore e solo complementare, ed interviene solamente dopo che la responsabilità sia stata accertata e la sanzione sia stata irrogata, mirando appunto alla seconda fase: il reinserimento del condannato nel tessuto sociale.
Confondere o invertire questa gerarchia rischia di svuotare la pena della sua funzione essenziale.
Oltretutto una sanzione che non sia percepita come effettivamente afflittiva e proporzionata non può assolvere né al compito di prevenire nuovi reati né a quello di ristabilire l’equilibrio giuridico violato e garantire la sicurezza collettiva per il tramite dell’allentamento del pericolo stesso (il reo) dal contesto sociale.
Paradossalmente la rieducazione stessa, per essere credibile agli occhi del reo, presuppone la certezza e l’effettività della pena e non può in alcun modo sostituirsi ad esse. Un percorso di reinserimento non può fondarsi sulla percezione di impunità, né può prescindere dal riconoscimento della responsabilità per il fatto commesso. Se la pena perde incisività, non solo viene meno la deterrenza, ma si incrina il patto sociale che attribuisce allo Stato il monopolio della forza legittima in cambio della garanzia di giustizia.
Non è soltanto una questione politica, ma anzitutto culturale
Il dibattito politico recente tende a concentrare l’attenzione sull’inasprimento normativo, quasi che la severità formale delle pene possa di per sé essere sufficiente a garantire maggiore sicurezza. Perché è evidente che, se le forze dell’ordine operano con professionalità, puntualità ed una efficacia adeguata alle risorse disponibili, se l’ordinamento dispone di un impianto normativo strutturalmente coerente e se il legislatore continua a intervenire con nuove disposizioni, il nodo critico non può che essere individuato nell’effettività dell’applicazione.
In uno Stato di diritto, la sovranità popolare si esprime attraverso il Parlamento che legifera, ma si realizza concretamente solo qualora le norme trovino attuazione coerente e prevedibile nella prassi giudiziaria. Quando questo circuito si interrompe, la distanza tra legge e realtà diviene terreno fertile per sfiducia e disaffezione.
Il nocciolo della questione, allora, non è se occorrano pene più severe, né se servano nuove leggi simboliche come quella sul femminicidio, strumenti che così pensati divengono armi per gli azzeccagarbugli, ma è garantire all’ordinamento coerenza tra norma, applicazione e conseguenza perché un sistema penale che moltiplica i divieti ma fatica ad assicurarne l’effettività delle pene non rafforza l’autorità dello Stato: la indebolisce.
La sicurezza non nasce dall’enfasi legislativa, ma dalla credibilità delle istituzioni, e la credibilità si fonda su un principio semplice quanto antico: la legge deve essere chiara, applicata con equilibrio e, soprattutto, certa nelle sue conseguenze. Senza questa certezza, ogni decreto sicurezza rischia di restare un inutile esercizio di retorica.
Potrebbe interessarti anche:
Coltelli a scuola: quanto è pericoloso il mondo degli studenti?
La legge sul consenso “libero e attuale”: perché non funziona?
Quale Italia nel discorso di fine anno del Presidente Mattarella?