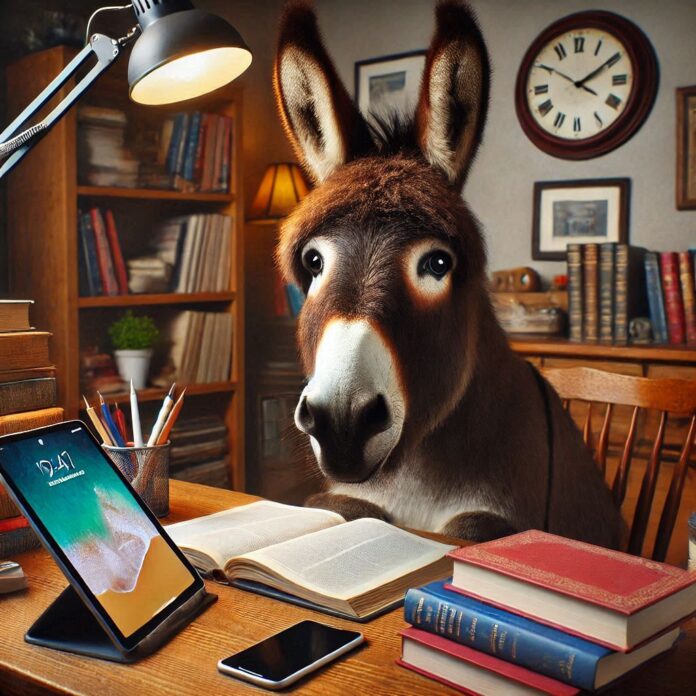Scuola, media e social: l’Italia è il Paese degli ignoranti. Siamo pronti al salto d’epoca? Il nuovo rapporto Censis 2024
Da italiana, mi sono spesso chiesta quanto siamo davvero pronti ad affrontare le sfide di un mondo che cambia rapidamente. Ogni giorno leggiamo di innovazioni tecnologiche, trasformazioni sociali ed economiche, ma noi italiani, siamo culturalmente preparati a questo salto d’epoca?
La risposta, guardando alcuni dati, lascia perplessi e scoraggiati. Viviamo in un Paese che sembra aver smarrito le sue radici culturali e il senso profondo dell’educazione. E questo non è solo un problema di numeri, ma una questione che tocca le basi della nostra identità collettiva e della capacità di costruire un futuro condiviso.
L’Italia sembra trovarsi di fronte a una sfida epocale: prepararsi a un mondo sempre più complesso e interconnesso, in cui la conoscenza diventa una risorsa fondamentale per la cittadinanza attiva e consapevole. Eppure, i dati mostrano un Paese in difficoltà, non solo per la mancanza di competenze di base ma anche per la diffusione di pregiudizi e stereotipi che trovano terreno fertile nell’ignoranza. Questo fenomeno non è solo un problema individuale ma un ostacolo al progresso collettivo.
I dati che emergono dall’ultimo rapporto Censis 2024, sembrano confermare le mie perplessità.
Il Paese degli ignoranti
Il capitolo «La società italiana al 2024» del 58° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese riporta che, per quanto riguarda il sistema scolastico, non raggiungono i traguardi di apprendimento in italiano, il 24,5% degli alunni al termine della scuola primaria, il 39,9% al termine delle medie, il 43,5% al termine delle superiori (negli istituti professionali il dato sale vertiginosamente all’80,0%). In matematica: il 31,8% alle primarie, il 44,0% alle medie e il 47,5% alla scuola superiore (il picco si registra ancora negli istituti professionali, con l’81,0%).
Il 49,7% degli italiani non sa indicare correttamente l’anno della Rivoluzione francese, il 30,3% non sa chi è Giuseppe Mazzini (per il 19,3% è stato un politico della prima Repubblica), per il 32,4% la Cappella Sistina è stata affrescata da Giotto o da Leonardo, per il 6,1% il sommo poeta Dante Alighieri non è l’autore delle cantiche della Divina Commedia.
Mentre si discute di egemonia culturale, per molti italiani si pone invece il problema di una cittadinanza culturale ancora di là da venire (del resto, per il 5,8% il «culturista» è una «persona di cultura»). Nel limbo dell’ignoranza possono attecchire stereotipi e pregiudizi: il 20,9% degli italiani asserisce che gli ebrei dominano il mondo tramite la finanza, il 15,3% crede che l’omosessualità sia una malattia, il 13,1% ritiene che l’intelligenza delle persone dipenda dalla loro etnia, per il 9,2% la propensione a delinquere avrebbe una origine genetica (si nasce criminali, insomma), per l’8,3% islam e jihadismo sono la stessa cosa.
La crisi del sistema educativo
La scuola, che dovrebbe essere il pilastro della formazione culturale e civile, sembra non riuscire a garantire livelli di apprendimento adeguati. Secondo i dati, al termine delle scuole superiori quasi la metà degli studenti non raggiunge i traguardi minimi in italiano e matematica, con percentuali drammatiche negli istituti professionali. Ma cosa significa realmente questa difficoltà nell’apprendere? Non si tratta solo di numeri, ma di giovani che escono dal sistema scolastico senza gli strumenti per comprendere il mondo che li circonda, senza capacità critiche e senza consapevolezza storica.
Ad esempio, il fatto che il 49,7% degli italiani non conosca la data della Rivoluzione francese o che una percentuale significativa attribuisca la Cappella Sistina a Giotto o Leonardo non è solo un aneddoto curioso: è il segnale di una lacuna culturale che rende difficile contestualizzare gli eventi, comprenderne l’importanza e trarre lezioni per il presente. La storia, l’arte e la letteratura non sono solo materie da studiare per superare un esame, ma chiavi per interpretare la realtà.
Le conseguenze dell’ignoranza diffusa
Quando mancano conoscenze di base, si diventa più vulnerabili a stereotipi, pregiudizi e narrazioni semplificate. Il 20,9% degli italiani crede che gli ebrei controllino il mondo tramite la finanza; il 15,3% considera l’omosessualità una malattia; il 13,1% ritiene che l’intelligenza dipenda dall’etnia. Questi dati non sono solo numeri, ma rivelano una società che fatica a distinguere tra informazione e disinformazione, tra realtà e pregiudizio.
L’ignoranza crea un terreno fertile per ideologie pericolose e atteggiamenti discriminatori, ma ha anche conseguenze più sottili: limita la capacità di partecipare al dibattito pubblico, di comprendere le decisioni politiche o di sfruttare le opportunità offerte da un mondo globalizzato. In un contesto del genere, parlare di “egemonia culturale” rischia di sembrare un esercizio elitario, quando invece il vero problema è costruire una “cittadinanza culturale” capace di includere tutti.
Le radici del problema
Le cause di questa situazione sono molteplici. Da un lato, c’è una crisi strutturale del sistema educativo, che fatica a innovarsi e a rispondere ai bisogni di una società in rapida trasformazione. Dall’altro, c’è una responsabilità collettiva: la cultura, intesa come patrimonio condiviso, è stata spesso relegata a un ruolo marginale, percepita come qualcosa di superfluo o elitario.
Anche i media e i social network hanno un ruolo in questa crisi. L’accesso immediato a informazioni non filtrate e spesso non verificate ha reso più difficile distinguere tra verità e falsità, favorendo la diffusione di credenze errate. Inoltre, la frammentazione delle fonti di informazione contribuisce a creare bolle di isolamento culturale, dove ognuno trova conferma alle proprie idee preconcette.
Verso una nuova idea di cittadinanza culturale
Cosa significa, allora, essere culturalmente preparati al salto d’epoca? Significa dotarsi degli strumenti per comprendere un mondo complesso, per partecipare attivamente alla vita democratica e per costruire una società inclusiva. Ma questo non può avvenire senza un investimento serio nella cultura e nell’educazione.
Occorre ripensare il sistema educativo, non solo dal punto di vista dei contenuti ma anche dei metodi. Le scuole devono diventare luoghi di formazione critica, dove gli studenti imparano a mettere in discussione le informazioni, a collegare fatti e idee, a sviluppare empatia e curiosità. Anche le famiglie e le comunità locali devono giocare un ruolo attivo, promuovendo il valore della cultura come strumento di emancipazione.
Infine, è necessario un cambiamento culturale più ampio. Bisogna superare l’idea che la cultura sia un lusso per pochi e iniziare a vederla come un diritto fondamentale, essenziale quanto la salute o la sicurezza. Solo così sarà possibile costruire una società davvero pronta ad affrontare le sfide del futuro.
La strada è lunga e complessa, ma non ci sono alternative: senza conoscenza non c’è progresso, senza cultura non c’è libertà.
Immagine di copertina generata con IA Bing
Potrebbe interessarti anche:
Politically correct e cancel culture: non è che stiamo esagerando?
Professionisti a rischio a causa dell’Intelligenza Artificiale?