Scientificamente si chiamano testi “espografici”. Sono le parole scritte, i video esplicativi, ma più che altro sono i testi brevi o lunghi che si trovano, in mostre e musei , accanto alle opere esposte. Il famoso “cartellino” appunto, o per usare un linguaggio più editoriale la “didascalia”.
Sono quelle le parole che, comprensibili o no, ci accompagnano lungo tutto il percorso della mostra. I testi espografici, infatti, sono nati proprio con il compito di informare, di accompagnare, di rendere le mostre e le opere più fruibili. Hanno un ruolo didattico preciso. Insomma il cartellino è il nostro tutor, la nostra guida virtuale.
Il cartellino, la stretta di mano delle mostre
Ma a volte, spesse volte purtroppo, il cartellino diventa un qualcosa che invece di avvicinare alla mostra, ce ne allontana. Eppure è il biglietto da visita del curatore. É l’attimo della “prima impressione”. I famosi trenta secondi, la stretta di mano in cui ci si gioca tutto.


Immaginiamoci dentro a una mostra. Ingresso, prima sala: le persone sono tutte ferme intorno ai pannelli introduttivi, i visitatori prima di «guardare» un’opera, la «leggono». Primo piano su didascalia e commento, sul testo espografico appunto. Che dovrebbe aiutare i visitatori, tutti i visitatori, a capire, comprendere…
Arte e cultura diventano simboli di fatica
Invece ci imbattiamo in caratteri piccolissimi, con colori che si confondono con lo sfondo, molto spesso situati troppo in basso. I visitatori si accalcano, si chinano tutti insieme sui testi e molte volte se ne allontanano. Frustrati, delusi. Troppa, gente, troppo lontano, anzi di questi tempi troppo vicini…. Arte e cultura diventano da subito sinonimo di non comprensione, di fatica, ci si accosta alle opere già con il disagio di non aver potuto leggere la spiegazione, che non fa altro che alimentare il preconcetto che l’arte sia comprensibile solo a un ristretto pubblico di “addetti ai lavori”.
Insomma il mondo dei musei e delle mostre, e a ruota quello dei curatori, usa i muri come la pagine di un catalogo: informazioni enciclopediche, parole roboanti, omaggi ai collezionisti e ai prestiti, informazioni utili si, certo.. Ma sono emozionanti? Riescono a far amare l’arte? A far guardare l’opera in un certo modo?
Le mostre sono emozioni
Lasciamo queste domande in sospeso. Ognuno di noi ha di certo la sua risposta. Da parte nostra ci limitiamo semplicemente a notare che le mostre e i luoghi museali sono posti in cui si legge in piedi e a distanza. Luoghi che che impongono un linguaggio del tutto diverso da chi guarda un catalogo seduto in poltrona.
Chi va a vedere una mostra ha delle aspettative: di piacere, di sensazione, vuole emozionarsi. Difficile con le scritte minuscole di un cartellino volto più a mostrare la conoscenza del curatore che avvicinare il pubblico all’arte. Il modo in cui vengono redatti i testi espografici dimostra quale tipo di dialogo il curatore vuole instaurare con il suo pubblico. In quale considerazione lo tenga.
I testi sono la narrazione emotiva
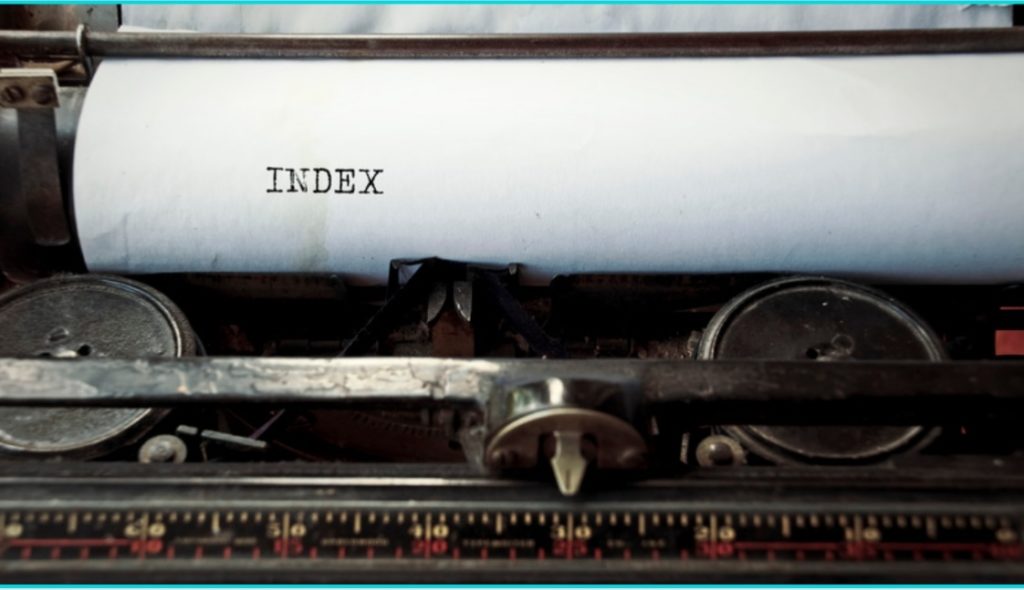
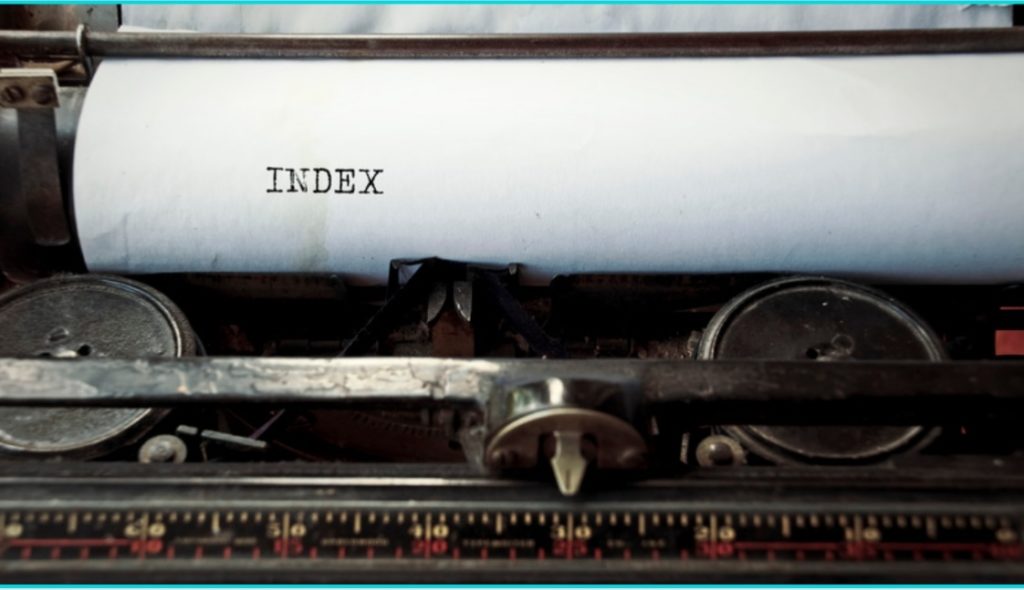
I testi espografici non devono intimidire, non far sentire “all’altezza”. Quante volte si sente dire che un testo è troppo difficile piuttosto che mettere in discussione il progetto curatoriale? Le emozioni nelle mostre scaturiscono spesso proprio dalla lettura dei testi di accompagnamento. Dal “cartellino”. Che dovrebbe farsi narrazione emotiva, suggestione, parte integrante e non strumento noioso e imperante della mostra.
È un argomento molto discusso e dibattuto questo. L’élite dei musei contro il grande pubblico che alla fine è colui che determina il successo o meno di una mostra in termini di presenze.
Non è che i curatori dovrebbero farsi insegnare qualche regola dai pubblicitari che.. pare che di muri se ne intendano abbastanza?


