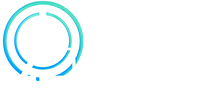Corsi e ricorsi storici, un film, “Quo vado?” appunto, che è un manifesto dell’italiano medio, all’estero e in patria, e un virus sul quale probabilmente non ci hanno detto veramente tutto.
1969 – 2020: non è cambiato niente. Quo vado?
1969
Avevo otto anni all’epoca e i ricordi sono in parte sbiaditi, ma alcune cose sono ben stampate nella memoria: mio padre che andava imperterrito a lavorare, guai a mettersi in mutua, mia madre che altrettanto impunemente usciva a “comprare” al mercato, tutte le sante mattine, la nonna che guai se perdeva le messa delle sette (rigorosamente di mattina), e io che andavo regolarmente a scuola, in una costruzione prefabbricata, a base di pannelli di eternit (si, proprio di amianto).
Non ricordo se in quell’inverno “ho fatto l’influenza”, e non ricordo quel servizio del Telegiornale, ma riguardandolo mi rendo conto di come, dopo cinquantuno lunghi anni, non sia cambiato un cazzo.
“Quanto Mao starnuta il mondo si ammala”, dice spavalda la voce narrante: all’epoca non c’era il politically-correct, e certe affermazioni passavano tranquille. Non c’erano i social, per fortuna, e quindi l’italiano medio non poteva tramutarsi con nonchalance da critico musicale a virologo, passando per meteorologo, piuttosto che geniopontiere.
Ma la sostanza resta la stessa: l’epidemia era partita da Hong Kong e aveva colpito l’Italia. Ben 13 milioni di italiani costretti a letto, ovvero un italiano su quattro, e almeno 5000 morti per l’influenza cinese. Il nome che le fu dato era davvero nel segno dei tempi: era appunto il 1969 e la “spaziale” si diffuse prima in Asia, poi negli Stati Uniti e infine arrivò in Europa.
2020
Per dovere di cronaca: la “spaziale”, è stata la terza pandemia del Ventesimo secolo, dopo l’influenza “spagnola” del 1918, e l’influenza “asiatica” degli anni ’50”.
Tutto questo non è servito a tenerci pronti per future pandemie, o epidemie: #iorestoacasa è il nome dato dal Premier Giuseppe Conte, al pacchetto di normative per chiudere la stalla, quando i buoi erano ormai già scappati. Spiace sottolinearlo, ma è così.
Le norme, ricordo che la trasgressione è un reato perseguibile per legge, sono semplici, forse non troppo chiare, questo sì, ma vanno rispettate, che ci piaccia o meno.
A quanto pare, non ci piace: da buon italiano medio, c’è qualche cretino (vorrei dire di peggio, ma la deontologia professionale me lo impedisce), che sui social (purtroppo adesso ci sono, contrariamente al 1969), istiga ad uscire, a “socializzare”, nonostante le restrizioni, c’è una corsa completamente ingiustificata all’accaparramento alimentare, che non si è vista neanche ai tempi del Disastro di Černobyl’, c’è addirittura chi prevede un incremento delle violenze famigliari, a causa della forzata convivenza.
Il maestro Indro Montanelli, diceva in tempi non sospetti: “italiani un popolo di pagliacci”.
Un americano a Roma
Pagliacci sì, fino a poco tempo fa, con l’autoradio sempre nella mano destra, ma fino a un certo punto.
Ho due figlie che vivono e lavorano all’estero: la più grande in Galles, e la più piccola in Alsazia.
Entrambe stanno vivendo sulla propria pelle, in questo particolare momento, il dramma di essere italiane, un po’ come Checco Zalone nel film “Quo vado?”. Dramma perché dagli stranieri, sudditi di Sua Maestà la Regina, o sanculotti gallici poco importa, ci vedono come gli “untori” d’Europa.
In Francia per il momento sono più contenuti, questo va detto, ma la paura è che si adeguino in fretta, mentre nel Regno Unito, siamo al razzismo puro, cattivo, e pure violento.
Siamo lontani anni luce, purtroppo, dal classico: “italiano pizza e mandolino”.
Ma in questi frangenti, soprattutto all’estero, viene fuori l’Italia che non si spaventa, anzi, l’italiano che non si spaventa.
Sono un italiano, un italiano vero
Mi raccontano le due ragazze, che la comunità italiana all’estero, è unita più che mai, tramite quella parola che è nostra croce e delizia: solidarietà.
Quando c’è da aiutare, da aiutarsi, l’italiano c’è, sempre e comunque: che sia pagliaccio o paraculo, fatto da sè o raccomandato, non importa. E sono sicuro che sarà anche così qui da noi, perdonatemi il termine magari enfatico, in patria: finita la corsa all’accaparramento, finiti i video idioti, finiti i tuttologi, se ci sarà da aiutare qualcuno, lo faremo.
Perché noi siamo fatti così.
Come diceva il grande Giorgio Gaber: “Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono”.